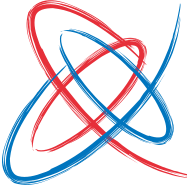Viktor Mihály Orbán è un politico ungherese, più volte primo ministro, carica che riveste ancora oggi. Nato nel 1963, si laureò in Giurisprudenza a Budapest nel 1988 (con una tesi su Solidarnosc), fondando quello stesso anno, assieme ad altri attivisti, la Federation of Young Democrats (embrione del futuro partito Fidesz – Unione Civica Ungherese), movimento anticomunista, nonostante lo stesso Orban avesse militato in precedenza nelle organizzazioni giovanili del partito. Dopo un breve periodo di studi ad Oxford (finanziata proprio da quella fondazione Soros contro la quale un domani si scaglierà), tornò in patria nel 1989 quando cadde il regime socialista. Fu tra i primi a chiedere il ritiro delle truppe sovietiche, celebrando in discorsi ufficiali i leader della rivoluzione del 1956, a cominciare da Imre Nagy, imprigionato e ucciso dopo il fallimento dell’iniziativa. La transizione verso la democrazia e il multipartitismo permise ad Orban di essere eletto deputato presso l’Assemblea nazionale. Divenuto leader indiscusso del partito Fidesz, sotto la sua guida la forza politica nata con una linea liberal progressista, assunse un orientamento sempre più conservatore e nazionalista. Tale evoluzione si colloca agli inizi del nuovo millennio, dopo che le riforme liberiste e l’apertura ai mercati internazionali generarono più svantaggi (come la perdita di diritti e garanzie per i lavoratori), che benefici per la cittadinanza. In sostanza, si trattò di una svolta in senso sovranista e nazionalista, impressa da Orban con la volontà dichiarata di difendere l’autonomia del suo paese rispetto agli investitori stranieri; allo stesso tempo veniva definitivamente rigettato passato comunista, tanto da farne menzione anche nella nuova Costituzione. Nel 1998, grazie ai risultati elettorali, Orban fu nominato per la prima volta premier di un governo di coalizione: tra i primi provvedimenti adottati una riforma della pubblica amministrazione e un rafforzamento delle prerogative del capo dell’esecutivo, con una contestuale limitazione di quelle parlamentari. Allo stesso tempo, il governo rinnovò molte delle posizioni chiave all’interno del settore pubblico, insediandovi uomini fedeli al nuovo leader, come, ad esempio, il presidente della Banca nazionale ungherese o il procuratore capo della città di Budapest. La legge sullo status del 1999 prevedeva una serie di misure a favore delle minoranze etniche rumene, slovacche, ucraine e delle nazioni della ex Iugoslavia, criticate da diversi dei paesi d’origine, che la giudicarono una indebita interferenza nei loro affari interni; il secondo governo Orban (2008/2012) ha previsto misure più semplici per la concessione della cittadinanza alle stesse minoranze. Nel corso del primo mandato di Orban, l’Ungheria aderiva alla NATO, primo paese dell’ex Patto di Varsavia a farne parte, assieme a Polonia e Repubblica Ceca: tra le iniziative del Patto Atlantico che hanno coinvolto Budapest, ricordiamo la missione ISAF (in Afghanistan) e la guerra in Iraq. Tra il 2002 e il 2006, sconfitto alle elezioni dai socialisti, il Fidesz divenne il principale partito d’opposizione, ma la vittoria alle amministrative del 2006 e al referendum del 2008 sul sistema tariffario della sanità pubblica segnò il rilancio di Orban; in ogni caso, pure all’opposizione, il Fidesz vinse le europee del 2004, riuscendo l’anno seguente ad eleggere un proprio esponente, László Sólyom, alla presidenza della Repubblica. Nel 2010 Orban vinse le elezioni politiche, tornando alla guida dell’esecutivo con una solida maggioranza, in coalizione con i cristiano democratici. Nel corso della nuova legislatura furono varate importanti (e controverse) riforme costituzionali e legislative, diverse delle quali costeranno ad Orban l’accusa di aver provocato un’involuzione autoritaria del paese; nel 2012 una legge speciale riconosceva lo status delle confessioni ebraiche e cristiane, mentre per islamici e buddhisti analoghe misure furono approvate solo due anni più tardi. Nuove modifiche costituzionali – che tra l’altro disciplinano l’efficacia delle sentenze e le prerogative della Corte costituzionale e impedivano ai tribunali ordinari di annullare le leggi approvate dal parlamento con una maggioranza qualificata -, sono state approvate nel 2014. Tra le numerose leggi volute dal partito di Orban, ricordiamo quelle che mettono al bando l’ideologia comunista, la regolazione della propaganda elettorale, la tutela della famiglia intesa in senso tradizionale. Confermato nelle tornate elettorali del 2014 e del 2018, Orban è sempre rimasto alla guida del governo, palesando una spiccata tendenza – secondo i maggiori critici – al populismo. In particolare, al centro delle polemiche figura la netta contrarietà di Orban sulla questione dei flussi migratori, nonostante proprio l’assenza di controlli da parte del governo di Budapest abbia aperto le porte dell’Europa, nel corso del 2015, ad importanti migrazioni da Nordafrica, Siria e Pakistan, transitati dal territorio ungherese. Giusto per rendere l’idea circa il pensiero di Orban sui migranti, riportiamo alcune sue dichiarazioni riprese da un recente numero della rivista Limes: “ogni singolo migrante è un rischio per la sicurezza pubblica”; “per noi la migrazione non è una soluzione, ma un problema [..] non è una medicina, ma un veleno che non vogliamo ingoiare”; “i rifugiati musulmani sono degli invasori”; “vogliamo che le nostre politiche siano costruite per le famiglie [..] dobbiamo porre la famiglia di nuovo al centro delle politiche europee. A partire dal 2015, si è palesato sempre più l’orientamento anti-immigrazione del governo Orban, con la creazione di barriere ai confini con la Serbia e rinforzando il Gruppo di Visegrad (alleanza politica fondata nel 1991, che riunisce Ungheria, Polonia, Repubblica ceca e Slovacchia. Orban si è sempre opposto fermamente a ogni politica europea di gestione dei flussi o redistribuzione degli immigrati, una linea politica confermata da un referendum popolare tenutosi nel 2016, che però non raggiunse il quorum di validità: ciò nonostante, il 98 per cento dei votanti – il 43 per cento degli aventi diritto – si espresse a favore di Orban. Se per il leader politico “Le famiglie e i figli sono sicuramente una benedizione, non solo per la nazione ma per l’intera comunità europea”, l’Ungheria – nonostante una serie di misure per incentivare nascite e matrimoni – è tra gli stati europei che manifesta più chiaramente i segnali del calo demografico, il che alimenta le critiche verso le politiche contrarie alle migrazioni, che per alcuni osservatori rappresenterebbero un buon antidoto alla crescita zero e all’invecchiamento della popolazione. Del resto, nonostante nel 2004 l’Ungheria sia entrata nella UE (ma non nell’euro), Orban non ha mai celato il suo euroscetticismo e sono state proprio le sue politiche anti-migratorie (e le accuse di scarso rispetto delle garanzie democratiche) ad essergli costate, nel 2019, la sospensione del Fidesz dal Partito Popolare Europeo (PPE); in realtà, si trattò di una scelta di compromesso, per scongiurare l’espulsione, ma nel 2021 è stato lo stesso Fidesz ad uscire definitivamente dal PPE. Tra le dichiarazioni più marcatamente antieuropeiste di Orban, ricordiamo quella secondo cui occorrerebbe “liberarsi dai dogmi e dall’ideologia occidentale europea”. Già nel 2015 Jason Pack, analista geopolitico, parlava della rinascita nel paese di forme di nazionalismo antiglobalista, mentre di tendenze dittatoriali del premier parlava la testata politico.com, riprendendo le parole dello stesso Orban, dove parlava dell’edificazione di uno stato “illiberale”, inteso più che altro come rigetto delle tendenze globaliste (il riferimento era alle élite europeiste e all’FMI) e volontà di ribadire l’indipendenza della nazione; secondo le sue stesse parole: “i sistemi politici non occidentali, non liberali, e non democratici possono comunque portare al successo una nazione”. Si comprende bene, a questo punto, come la figura di Orban sia sempre più stata inserita nel novero dei politici cosiddetti “antiglobalisti”, anche per via degli stretti rapporti instaurati con altri leader internazionali della stessa “famiglia” come il presidente americano Donald Trump (con la nuova Amministrazione Biden, difatti, le relazioni con Washington si sono raffreddate) e con quello cinese Xi Jinping. Importanti rapporti, inoltre, sono stati allacciati col leader turco Recep Erdogan: con Ankara è stato creato un consiglio di cooperazione, una sorta di ponte tra Europa e Turchia, e creata una partnership basata sulla dottrina ottocentesca del turanismo, che affonda sulle comuni radici uralo-altaiche dei due popoli, quasi a voler sottolineare il distinguo (e la contrapposizione) rispetto ad altre nazioni europee (ed ai sogni egemonici), come quelle di lingua tedesca o slava. A fine 2019 sono stati consolidati, con una serie di accordi economici, anche i rapporti col Giappone dell’allora premier Shinzo Abe; importanti relazioni esistono con Israele, in particolare con l’ex premier Benjamin Netanyahu. Tra i politici coi quali esistono contatti e attestati di stima, ricordiamo il presidente russo Vladimir Putin, o i politici italiani Matteo Salvini e Giorgia Meloni, fatto rinfacciato loro anche nell’attuale campagna per le elezioni del 25 settembre 2022. A paesi come Turchia, Singapore, Russia e Cina (non tutti precisamente esempi di democrazia), Orban ha costantemente dichiarato di ispirarsi come modelli di sovranismo, tutela della cultura e delle tradizioni, piena occupazione. Dicevamo di alcune e controverse riforme istituzionali, approvate ed entrate in vigore nel 2012 (tra le altre cose, veniva modificata la denominazione ufficiale dello stato da Repubblica d’Ungheria a Ungheria tout court) e salutata da Orban come un completamento della transizione democratica, oggetto di molte critiche in quanto considerate lesive delle libertà democratiche. Tra queste le disposizioni sulla libertà di espressione e di stampa o sulle prerogative e l’indipendenza del potere giudiziario (il locale CSM viene, nei fatti, subordinato all’Esecutivo); Orban, inoltre, si è a più riprese dichiarato a favore della reintroduzione della pena di morte (ma non lo ha inserito in Costituzione). Sul versante della libertà d’informazione, a parte la creazione di una commissione di controllo sui media, si è assistito nel tempo ad una compressione delle voci libere, mentre la proprietà e la direzione di molte testate sono finite in mani fidate per Orban. Nel luglio 2020 IlPost.it riportava la seguente notizia: “Szabolcs Dull, direttore dell’importante giornale ungherese Index.hu, è stato licenziato per aver parlato delle pressioni esercitate dal governo ungherese sul suo giornale, uno dei pochi ancora indipendenti nel paese”, aggiungendo dei ripetuti tentativi del governo di assumere il controllo dei media, anche attraverso la creazione di una fondazione, sotto la cui egida dovrebbero operare centinaia di organi d’informazione del paese; nei fatti, circa il 90 per cento dei media controllato, direttamente o indirettamente, dal governo Nel 2020 nuove leggi hanno promosso un modello educativo dei più piccoli fondato su valori nazionali e cristiani, pur senza vietare esplicitamente le unioni civili; allo stesso tempo, è stato proibito il riconoscimento legale del cambio di sesso (ritenuto fondato esclusivamente su nascita o genoma), decisione costata ad Orban dure critiche da parte di Amnesty International. L’anno seguente è stata vietata la rappresentazione di modelli ispirati all’omosessualità in film, pubblicità e nelle scuole, giustificando le misure come strumento di protezione per genitori e minori. Come sapete, noi non siamo qui per esprimere giudizi o valutazioni di merito, ma per fornirvi una seria d’informazioni ed elementi, che consentano a ciascuno di formarsi un’opinione il più possibile imparziale: per questo daremo conto anche di posizioni diverse sulla figura di Orban, espresse anche nel nostro paese. È innegabile che in Italia le parole “dittatore” o “dittatura” – al pari di quelle di razzismo ed etichette varie ed eventuali – vengano usate e abusate (se non distorte), tendenza resa più agevole quando si ascolti una sola scuola di pensiero. Proprio per questo, diamo spazio alle posizioni del prof. Marco Gervasoni, docente universitario di Storia contemporanea, ripresa da Il Giornale dell’aprile 2020 (oltre che dalla testata Affari italiani); ricordando le proteste avanzate dall’ambasciatore ungherese a Roma (sulla natura autoritaria del suo governo), lo studioso scrisse: “Perché un regime sia considerato dittatoriale occorrono almeno tre requisiti: assenza di ricambio della classe politica (cioè niente elezioni); concentrazione del potere in una sola figura o organo, senza check and balances; violenza politica del potere contro gli oppositori. Ora nessuna delle tre è presente in Ungheria, visto che si vota – l’opposizione ha appena vinto il comune di Budapest, non proprio una piccola città – il potere non è concentrato solo in Orban, perché funzionano Parlamento e Corte costituzionale, oltre che un capo di Stato. Infine, non pare che gli oppositori siano in carcere o sia coartata la loro libertà: in altri paesi europei abbiamo visto proteste represse con maggior violenza che in Ungheria, dove i conflitti sociali sono più moderati che altrove”. A tali affermazioni, però, andrebbe aggiunto che il controverso meccanismo elettorale ungherese, una corte costituzionale composta per lo più da giudici vicini al governo e il controllo pervasivo sui media potrebbero contribuire a falsare il gioco democratico, mentre lo “stato di crisi dovuto alla immigrazione di massa”, più volte prorogato a partire dal 2015, ha dato vita ad una sorta di stato d’emergenza; a tal proposito, a maggio 2022 ne è entrato in vigore uno nuovo, stavolta collegato all’emergenza economica causata dal conflitto ucraino; molto contestata anche la decisione (gennaio 2021) di elevare a eroe nazionale Endre Frankó, militare in servizio presso una divisione filonazista nel corso della Seconda guerra mondiale. In merito alla politica economica, nel corso del primo mandato questa è stata ispirata ad una forte liberalizzazione e dalla riduzione del deficit, accompagnata da una serie di misure sociali per favorire l’occupazione e la stabilità dei prezzi: tra queste ricordiamo l’abbattimento di tasse e contributi per i più giovani, l’abolizione delle tasse universitarie e i benefit per le madri. La politica di Orban parve dare i suoi frutti, se si considera, sia pur con fasi alterne, la contrazione dell’inflazione e la crescita del PIL, che ha registrato nel suo complesso un +18 per cento a partire dal secondo decennio del nuovo secolo. A partire dal secondo esecutivo Orban, invece, l’indirizzo economico assunse sempre di più un orientamento statalista, con nuove imposte a carico dei settori bancario, delle telecomunicazioni e alimentare, varando la nazionalizzazione dei fondi pensionistici privati: per i redditi personali è stata prevista una imposizione fissa del 16 per cento. Il rafforzamento della banca centrale ungherese (i cui vertici sono designati dal governo) e la decisione di conservare la valuta nazionale (il fiorino), rifiutando di entrare nell’euro, hanno provocato nuove fratture con Bruxelles, che ha interpretato questa linea come una chiara manifestazione di sovranismo; del resto, già nel 2011 Orban disse apertamente come la pensava, nel corso della presidenza di turno della UE: “Noi non crediamo nell’Unione europea, crediamo nell’Ungheria, e consideriamo l’Unione europea da un punto di vista secondo cui, se facciamo bene il nostro lavoro, allora quel qualcosa in cui crediamo, che si chiama Ungheria, avrà il suo tornaconto.” Nel corso del suo terzo mandato (2014-2018), Orban ha rafforzato le relazioni politiche ed economiche con la Russia di Putin, mentre a partire dal 2017 sono peggiorate quelle con l’Ucraina per dissidi sulle minoranze magiare della Transcarpazia (regione dell’Ucraina occidentale), alle quali veniva impedito di usare la propria lingua nelle scuole: Budapest ha reagito ponendo una serie di ostacoli all’adesione di Kiev alla NATO e alla UE. Non dimentichiamo, però, che a fine giugno del 2022 c’è stato un meeting tra il premier ungherese e il presidente Volodymyr Zelensky, il quale ha pubblicato un tweet che sembra aprire ad un totale cambio di registro nei rapporti tra i due governi: “Ho avuto una fruttuosa conversazione con il primo ministro ungherese Viktor Orbán. L’ho ringraziato per il suo sostegno alla sovranità dell’Ucraina e per l’assistenza ai rifugiati ucraini durante la guerra. Siamo d’accordo nell’approfondire la cooperazione nel settore energetico. Gli sono grato dell’appoggio alla nostra candidatura all’adesione all’Unione Europea. L’ho invitato a visitare l’Ucraina”. Nel settembre del 2018 il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza un pacchetto di sanzioni contro l’Ungheria per violazioni dello stato di diritto, secondo l’articolo 7 del Trattato di Lisbona. Nello stesso anno, però, le elezioni generali hanno confermato la maggioranza per il partito di Orban, che col 49,27 per cento dei voti, ha ottenuto 133 seggi su 199 nell’Assemblea Nazionale; partendo dall’esito della consultazione – quasi coeva alla vittoria di Lega e 5stelle in Italia e di altre forze politiche considerate antieuropeiste in altri paesi – il giornalista Giulietto Chiesa parlava di “…aperta contrapposizione nei confronti di Bruxelles” e di un progressivo indebolimento della UE, specie di fronte a personalità politiche imprevedibili come Orban. Tra i nuovi provvedimenti voluti dal premier, la cosiddetta legge “Stop Soros” – finanziere di origine ungherese, considerato alfiere del globalismo e avversario politico di Orban, che lo aveva accusato di favorire l’immigrazione per ledere la nazione ungherese -, che impose una tassa del 25 per cento sulle donazioni fatte da ONG straniere (come la Open Society) che supportano i migranti; ricordiamo anche la legge votata dal Parlamento ungherese agli inizi del 2017, che prevedeva la chiusura della Hungarian American Central European University (CEU), la cui sede è stata spostata a Vienna, patrocinata proprio dal miliardario naturalizzato statunitense: il Washington Post parlò apertamente di una deriva autocratica ed illiberale del governo Orban, invocando l’intervento delle autorità della UE. Di deficit democratico e violazioni dello stato di diritto parlava, in una pubblicazione del gennaio dello stesso anno curata dalla Cambridge University, anche Roger Daniel Kelemen, giurista e docente di scienze politiche, riferendosi esplicitamente a Ungheria e Polonia. Lo scoppio della pandemia da Covid-19 ha portato all’approvazione della contestatissima legge del 30 marzo 2020, che in pratica conferiva poteri assoluti al premier, sanzionando col carcere la diffusione di fake news sulla pandemia; qualcuno disse che la democrazia ungherese era stata messa in quarantena, forse dimenticando analoghe misure varate in molti altri stati (Italia compresa); per la cronaca l’Ungheria è stato l’unico paese della UE ad acquistare il vaccino russo Sputnik. Il 20 giugno – dichiarata conclusa la fase emergenziale – i poteri speciali (che hanno portato al varo di quasi 200 decreti) sono stati dismessi dal premier, alcuni dei quali sono intervenuti anche sul mercato del lavoro, annullando importanti diritti sindacali. Ricordiamo che nel 2018 una legge speciale aveva conferito ai datori di lavoro il potere di imporre fino a 400 ore annue di straordinari ai loro dipendenti, norme che sono state equiparate all’approvazione di una nuova schiavitù per i lavoratori ungheresi, costretti ad operare come manodopera a basso costo per compagnie straniere. Una svolta in senso privatistico è stata varata nel 2020, nei settori della cultura e dalla sanità, con migliaia di enti e lavoratori privatizzati. Le ultime elezioni (3 aprile 2022) hanno ancora una volta confermato il governo Orban, attribuendo al suo partito 135 seggi su 199 nell’Assemblea Nazionale (con oltre il 53 per cento dei voti), prevalendo sulla composita coalizione avversaria (che andava dalla destra ai socialisti), guidata dall’economista Péter Márki-Zay, conservatore ed europeista, appartenente al Movimento per un’Ungheria per Tutti. Alla fine del mese di luglio, sono arrivati gli strali del Comitato di Helsinki per i diritti umani in merito alla politica di respingimento dei profughi promossa dal governo di Budapest; alcuni analisti parlato di una linea – ispirata al nazionalismo e al recupero dei territori perduti – che evoca similitudini col presidente russo Vladimir Putin. Proprio in merito ai rapporti con la Russia, il premier ha più volte e aspramente criticato la posizione della UE sulle sanzioni contro Mosca: pur avendo condannato l’aggressione del 24 febbraio, le ha definite prodromiche ad un’economia di guerra; in particolare, Orban si è opposto fermamente ad ogni estensione del regime sanzionatorio ai prodotti energetici – ottenendo una sorta di deroga in suo favore – lamentando che, in caso contrario, il prezzo più salato l’avrebbero pagato i suoi cittadini. Non è certo un caso se l’Ungheria sia stato l’unico membro di UE e NATO (ricordiamo che la Turchia non fa parte della prima) a negoziare con Putin nuove forniture gasiere (ma del resto ben dieci paesi UE hanno pagato le stesse forniture in rubli, aderendo alle condizioni imposte da Mosca). Orban, pur offrendo da subito aiuti e assistenza umanitaria agli ucraini, ha sempre rigettato l’invio di forniture militari a Kiev, sottolineando la volontà del suo paese di tenersi fuori dal conflitto, prendendo spunto dalle scelte compiute da paesi come Cina, India, Brasile e Sudafrica. La posizione di Budapest sul conflitto in corso ha creato, ancora una volta, dissidi e contrasti con Bruxelles. La Commissione UE ha recentemente deciso di sospendere i fondi del PNRR a Budapest, senza però adottare analoghe misure contro Varsavia ( a sua volta e a più riprese accusata di violazione dei principi dello stato di diritto); secondo i critici la disparità di trattamento dipenderebbe proprio dal diverso atteggiamento adottato dai due governi verso l’Ucraina, visto che la Polonia si è schierata incondizionatamente con Kiev, dando rifugio e asilo a molti profughi; inoltre, il diverso approccio sulla questione ha finito per creare un’importante frattura tra Varsavia e Budapest, ponendo di fatto termine (quantomeno congelando) gli accordi di Visegrad. In una recente dichiarazione, Orban – preso atto del fallimento della strategia sanzionatoria per indebolire la Russia – ha detto che: “Serve una nuova strategia, il cui obiettivo sia la pace e la formulazione di una buona proposta di pace. Il compito dell’UE non è schierarsi, ma stare tra Russia e Ucraina”. Ancora a fine maggio, le trattative tra UE e Ungheria non avevano portato ad alcuna soluzione, con Orban che rifiutava aiuti finanziari per nuovi oleodotti e raffinerie, domandando allo stesso tempo lo sblocco dei fondi europei. Solo a giugno si è giunti al varo del sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, col via libera del governo ungherese, ottenuto grazie ad una serie di modifiche rispetto all’impianto originario: spariscono, in particolare, le misure contro il patriarca russo Kirill (cui pure Orban, alla fine, aveva aderito) e restano fuori la più grande banca russa, la Sberbank, il sistema di pagamenti internazionali SWIFT, la Credit Bank of Moscow e la Russian Agricultural Bank. In ogni caso, le fratture in ambito UE esistono e sono palesi, tanto che The Guardian scrive che i contrasti che si sono creati formano i presupposti per una vera e propria resa dei conti; addirittura qualcuno, riprendendo le parole di George W. Bush del 2002 riferito ai paesi fiancheggiatori del terrorismo, ha parlato di un nuovo “asse del male”, questa volta in Europa, tra Russia, Ungheria e Serbia, denunciando prese di posizione, alleanze e visioni del mondo assai lontane dall’Occidente e dalla UE. Per cercare di sintetizzare la linea politica di Orban, leggiamo un passaggio dell’intervento di Daniele Santoro su Limes: “La ricostituzione della Grande Ungheria – anche solo come spazio culturale – richiede risorse di gran lunga superiori a quelle di cui dispone la piccola Ungheria di Orbán. Ma resta il riferimento geopolitico inevitabile della leadership magiara, che bilanciando a proprio vantaggio le direttrici di influenza imperiale che convergono su Budapest e marcando la propria peculiarità identitaria rispetto al liberalismo e al liber(tin)ismo promossi da Bruxelles ambisce – più modestamente – a lenire la ferita aperta dalle amputazioni del 1920.”, un quadro esaustivo anche sui rapporti tra Mosca e Budapest, che andrebbe inquadrato in uno scenario ben più ampio rispetto a quello disegnato da coloro che vedono in Orban una sorta di cavallo di troia dei russi in Europa. Ultimamente le condizioni economiche non sono incoraggianti, con inflazione e deficit di bilancio in crescita; nel mese di luglio ci sono state importanti proteste di piazza contro la riforma fiscale varata dal governo, che lederebbe interessi piccole imprese, ma l’opposizione resta divisa e il controllo su media – assieme all’esito delle recenti elezioni, alla diffusa corruzione e al sostegno di importanti gruppi economici – garantiscono all’Esecutivo Orban una posizione di forza. Negare questo, sarebbe negare la realtà dei fatti, che questo ci piaccia o meno è un altro discorso, che nulla ha a che vedere con l’analisi proposta.
di Paolo Arigotti