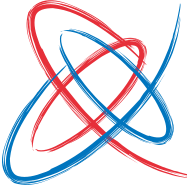E(U)XPLOITATION è il titolo dello studio che l’associazione Terra! ha dedicato al filo rosso che attraversa e accomuna le campagne europee ossia lo sfruttamento in agricoltura. Terra! è un’associazione ambientalista impegnata, tanto a livello locale che nazionale ed internazionale, in progetti e campagne sui temi dell’ambiente e dell’agricoltura ecologica. Dopo un’importante esperienza maturata nei campi e nei ghetti del nostro Paese, che ha prodotto progetti di inserimento sociale e lavorativo di soggetti fragili ed in stato di bisogno, l’associazione si è dedicata ad importanti inchieste e rapporti di ricerca, che hanno sollevato il velo sulle principali distorsioni presenti nel settore agricolo italiano. Da tempo Terra! racconta i meccanismi che governano l’economia del cibo dal campo allo scaffale. L’iniziativa ad esempio lanciata nel 2017, con la campagna #ASTEnetevi, ha denunciato una delle pratiche più vessatorie adottate dalla grande distribuzione organizzata (Gdo), quella delle aste al doppio ribasso, per riuscire a strappare il prezzo più basso di un prodotto che deve acquistare in grandi quantità, e che ha portato ad un disegno di legge correttivo.

Con questa nuova ricerca lo sguardo viene rivolto ad altri Paesi mediterranei, per individuare analogie e contrasti, al fine di denunciare i comuni squilibri e dare vita ad alleanze. Dall’Andalusia all’Agro Pontino, da Almeria alla Piana del Sele, dalla Grecia a Huelva, il rapporto compie un viaggio lungo la fascia mediterranea evidenziando i fenomeni che, con le dovute distinzioni, hanno interessato questi territori a partire dagli ottanta ma in maniera più accelerata dalla recessione del 2009: verticalizzazione delle filiere, defamilizzazione delle aziende, invecchiamento degli agricoltori e scarso turnover, impiego di manodopera di origine straniera. In tutte le nazioni analizzate la presenza di stranieri impiegati è molto elevata, con vaste sacche di irregolarità, che rivelano un settore in fase di riorganizzazione, in cui le condizioni lavorative sono strettamente collegate alle politiche migratorie nazionali e sovranazionali. La centralità dei profitti nell’agroalimentare spinge a ricorrere al lavoro straniero, perché flessibile e malpagato. In Italia le vicende delle rivolte di Rosarno, che attirarono per la prima volta l’attenzione dei media e della politica sulle condizioni di migliaia di lavoratori, segnarono uno spartiacque e determinarono un intervento istituzionale in materia di sfruttamento lavorativo e di reclutamento in agricoltura. L’adozione di leggi nazionali di contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro, come la legge n.199 del 2016, costituiscono un’eccezione nel meridione d’Europa ed insieme al Piano triennale di contrasto al caporalato approvato il 22 febbraio del 2020 hanno avviato il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità e l’investimento sui servizi ai lavoratori.
L’intermediazione tra azienda agricola e lavoratore rappresenta un fattore strutturale delle relazioni di lavoro nel settore agricolo e il suo rafforzamento è andato di pari passo con l’espansione dell’agroindustria nel sistema capitalistico dei paesi del Sud. In Italia i volti degli intermediari sono tanti, dal caporale alle cooperative alle agenzie interinali. Un sistema quest’ultimo diventato pervasivo in Spagna che, nella corsa al profitto, veicola violenza ed irregolarità. Con accordi bilaterali e programmi decentralizzati i lavoratori vengono reclutati nei paesi di origine: si tratta del “modello Huelva”. Un modello che salda il bracciante ad un datore di lavoro, sulla base di una condizione assoluta ed imprescindibile per essere reclutati cioè il ritorno in patria dopo la stagione di raccolta. Questa condizione capestro vale soprattutto per le lavoratrici che, tra i vari requisiti richiesti per ottenere il lavoro, devono essere madri. Per il datore di lavoro il legame con un figlio nella patria di origine costituisce infatti una garanzia che la clausola del ritorno a casa sia rispettata.
Anche in Grecia la deregolamentazione sfrenata ha fatto spazio agli intermediari. A Manolada tra le coltivazioni di fragole opera il mastoura, che ogni giorno forma le squadre di lavoro per trasportarle nelle aziende agricole. In Grecia vi è un ritardo più evidente nei programmi di regolarizzazione così come nella normativa di contrasto allo sfruttamento.
In media e nel migliore dei casi, soprattutto in Spagna e Italia, dove le condizioni sono migliori rispetto alla penisola ellenica, il lavoro si connota di grigio, con datori di lavoro che ad esempio non registrano le giornate effettivamente lavorate dal bracciante. Ma non meno presente è il lavoro a cottimo, in cui la paga varia a seconda dei “mazzetti” di ortaggi lavorati o il lavoro nero. Questo quadro è stato stravolto dalla pandemia da Covid-19, in quanto la riduzione della mobilità ha destato allarme tra produttori e Stati, preoccupati di restare senza manodopera nei campi. L’emergenza sanitaria ha quindi gettato un faro sulle distorsioni della filiera agroalimentare e sulle condizioni di tanti lavoratori agricoli. Secondo vari studi la mobilità lavorativa ha seguito altri flussi, privilegiando i Paesi con paghe e condizioni migliori, come Regno Unito e Germania. Quasi ovunque gli Stati hanno prorogato i permessi di soggiorno, ma le condizioni di vita dei braccianti, in particolare migranti, sono peggiorate. I lavoratori agricoli sono stati trattati come braccia meccaniche, senza avere a disposizione dispositivi sanitari di protezione adeguati e gli insediamenti informali hanno continuato ad essere luoghi insalubri e senza servizi, ospitando uomini e donne senza alternative.
Il Covid-19 ha quindi portato alla luce i limiti della filiera, con aziende agricole piccole e medie che soffrono gli effetti delle restrizioni e le grandi catene invece dei supermercati, che hanno ottenuto grandi profitti. Questa polarizzazione è ormai evidente alle istituzioni europee, che hanno emesso una direttiva che vieta le pratiche commerciali sleali, messe in atto dalla Gdo nei confronti di produttori e consumatori. Tutto il settore agroalimentare europeo, in particolare nella fascia mediterranea, vede i produttori accomunati dalle stesse questioni, quali individualismo e scarsa organizzazione. Sono fattori di vulnerabilità nei tavoli negoziali, dove le catene dei supermercati usano l’arma del dumping, importando merci a prezzi più bassi di quelli del mercato interno o imponendo ai produttori locali di abbassare i prezzi, equiparandoli ad altri mercati. Ciò accade nel nostro paese rispetto ai produttori spagnoli e in Grecia in relazione ai turchi o agli egiziani, esterni al mercato europeo. Mentre il Sud Europa viene descritto come fuori dalle logiche della modernità, in realtà è il luogo dove si manifestano le aporie del mondo globalizzato, in cui il cibo diventa merce, fonte di profitto o di miseria. Il settore agricolo costituisce ancora uno dei principali motori di sviluppo del Sud Italia, in grado di generare investimenti e posti di lavoro. È qui che si concentra la quasi totalità della produzione ortofrutticola nazionale.
Se si guarda più da vicino, come ci presenta la ricerca, alcuni ambiti territoriali caratterizzati da coltivazioni di prodotti di eccellenza, come le zucchine e i kiwi nell’Agro Pontino, il pomodoro di Foggia, diverse condizioni indeboliscono il potere contrattuale degli operatori pugliesi, campani e laziali con gli altri attori della filiera agroalimentare, soprattutto con la Gdo. Le Organizzazione dei Produttori, nate sotto l’impulso europeo per contrastare il potere delle industrie, non riescono ancora ad imporsi lungo la filiera. In queste zone del Sud, cooperativismo e associazionismo, rispetto al Nord d’Italia, aggregano meno soggetti e faticano a bilanciare i negoziati e a valorizzare le proprie colture, evidenziandone tratti distintivi e legame con il territorio. Fra gli operatori agricoli si cerca di sfuggire alle pressioni della distribuzione organizzata, che influisce negativamente anche sui piccoli negozi di prossimità, scaricando il prezzo sui lavoratori, con salari inferiori a quelli previsti dai contratti provinciali.
La legge 199 del 2016, nota come “legge anti-caporalato”, ha introdotto pene severe tanto per il caporale, cioè la persona che svolge la funzione di intermediazione illecita tra datore di lavoro e lavoratore, quanto per l’imprenditore. Tra le pene previste vi è l’arresto in flagranza, la reclusione da 1 a 6 anni, il controllo giudiziario dell’azienda e la confisca dei beni. Dall’approvazione della legge, la parte della norma messa in pratica è quella più specificamente repressiva, mentre ancora inapplicata è quella proattiva, che deve combattere le cause. Il caporalato resta uno strumento di reclutamento ancora molto diffuso: il caporale forma rapidamente la squadra di lavoratori, la trasporta nei campi, provvede al vitto, e in cambio del servizio, trattiene una percentuale della paga dei braccianti. Il lavoro del caporale supplisce alla mancanza di servizi adeguati, che dovrebbero essere garantiti dalle istituzioni.
Non molto diversa è la situazione in Spagna. Poco prima dello stato di allerta per l’emergenza coronavirus, da Valencia a Toledo, da Malaga a Lleida, da Jaén a Saragozza, per settimane a fare notizia sono state le proteste di produttori e agricoltori in tutto il paese iberico. Con i trattori migliaia di agricoltori hanno interrotto strade, piazze, protestato, con scene dure, come cariche della polizia in Estremadura. All’origine della mobilitazione vi sono molteplici motivi, come la caduta dei prezzi all’origine, l’aumento dei costi di produzione, i dazi imposti dagli Usa, le previsioni di tagli agli aiuti della Politica Agricola Comune. Lepe comune della provincia di Huelva, da anni è il simbolo in Spagna delle condizioni in cui vivono immigrati sin papeles, che lavorano in nero nella campagna dei frutti rossi. Il relatore delle Nazioni Unite Philip Alston, che ha visitato la baraccopoli, ha definito le condizioni dei lavoratori di vera e propria vita da animali, tra le peggiori mai viste.
Lo studio di Terra! ci conduce infine in Grecia, dove l’economia del paese è essenzialmente composta da piccole e medie imprese, ed il settore agricolo è ampio e principalmente integrato da micro aziende e da aziende agricole a conduzione familiare. Anche qui si assiste ad un effetto a cascata delle pressioni nella filiera agroalimentare, dalle pratiche commerciali sleali che i produttori devono affrontare sul mercato, al modo in cui questa si trasferisce sui lavoratori. In posizione subalterna rispetto agli agenti all’ingrosso e dei grandi supermercati, ai produttori si chiedono prezzi sempre più bassi, ma per poter vendere a basso costo, l’unica strada è contrarre i costi di produzione, nel ridurre i quali il bersaglio primario è il lavoro.
L’indagine, allargata a più paesi, ha fatto emergere un tema che accomuna tutta Europa: la filiera del valore. Siamo abituati a continue offerte di prodotti sottocosto, prodotti ortofrutticoli a prezzi stracciati, ma forse è il momento anche in questo campo di invertire la rotta, aprire gli occhi su come e su chi vengono scaricati i costi reali di queste offerte che ci invadono ogni giorno. Lo sfruttamento nei campi, il lavoro grigio, il caporalato non sono altro che la spia più evidente di una filiera non sostenibile, di cui conosciamo poco o niente e il cui terminale siamo noi, i consumatori, mentre sia a monte che a valle sarebbe necessaria un’azione decisa delle istituzioni, sia nazionali che europee.
di Rosaria Russo