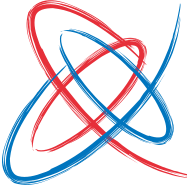Agli inizi del XIX secolo la Terra contava circa un miliardo di abitanti; si toccarono i 2 miliardi e mezzo nel 1950, si superarono i 4 nel 1980 e si giunse a 6 miliardi e 100 milioni all’inizio del nuovo millennio: attualmente il pianeta ospita circa 7,8 miliardi di persone (si ipotizza di superare gli 11 intorno al 2100). La popolazione residente in Italia al primo gennaio 2022 era pari a 58.983.122 individui (48,7 per cento uomini; 51,3 donne), con un’incidenza degli stranieri pari all’8,8 (gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2021 erano 5.171.894, circa l’8,7 per cento). La Regione più popolosa resta la Lombardia, con quasi 10 milioni di abitanti, mentre tra le città italiane svetta Roma (2.770.226). Un cenno alla distribuzione della popolazione residente: nel 2020 dei 7.903 comuni esistenti (quasi il 70 per cento dei quali di piccole o piccolissime dimensioni; ben 200 sono venuti meno per effetto delle fusioni), vede la popolazione risiedere per il 68,5 per cento nei comuni medi; quasi la metà dei residenti vive in pianura (49,1 per cento), un 38,8 in collina, mentre calano di un 2,2 i residenti nelle zone montane. La densità è maggiore nei comuni litoranei (396 abitanti per kmq), rispetto ai restanti (167). I dati collocano il nostro paese al terzo posto per numero di abitanti in Europa, dopo Germania e Francia, e al 25esimo posto al mondo (dato 2020). La popolazione è più o meno triplicata rispetto all’unificazione del 1861: erano quasi 29 milioni gli italiani dell’epoca – 26,3 secondo altre proiezioni – divenuti poco meno di 33 agli inizi del XX secolo, 47,5 subito dopo la Seconda guerra mondiale; occorre precisare che tali dati vanno interpretati con tutte le riserve del caso circa i numeri e la loro elaborazione, tenuto conto in quel periodo non esisteva un servizio statistico istituzionale e che solo nel 1989 l’ISTAT è divenuto ente di ricerca, e non più solo organismo deputato alla raccolta dei dati. Ad ogni modo, la diminuzione demografica nel nostro Paese, anche solo rispetto al 2014, sembra inarrestabile: dai 60,3 milioni, si è passati ai poco meno dei 59 attuali, mentre solo nel 2021 si sono persi 253mila residenti. Il dato negativo interessa maggiormente le regioni del Mezzogiorno, in particolare Molise (-12 per mille), Basilicata (-9,5) e Calabria (-8,6). Sono 25,6 milioni le famiglie italiane, mentre l’età media si attesta sui 46,2 anni (34,8 per gli stranieri); il dato è in aumento, nonostante la pandemia, rispetto alla precedente rilevazione che si fermava a 45,9. All’interno della cosiddetta piramide delle età (così chiamata per via della rappresentazione grafica dei dati), si riscontra una netta prevalenza della fascia 15-64 (63,5 per cento), seguita dagli over 65 (23,8) e dai 0-14 (12,7); 20.159 sono gli ultracentenari. Solo per rendere l’idea delle proporzioni tra le diverse classi di età, si calcola che per ogni bambino ci siano 5,1 anziani. L’aspettativa di vita è pari a 84,7 per le donne, 80,1 per gli uomini (con una media di 82,4). La elevata speranza di vita, tra le più alte al mondo, rappresenta un grande progresso, riconducibile alle migliori condizioni di vita e ai progressi della medicina e dell’igiene: basti pensare che, ancora nel 1880, il dato si fermava a 35,4 anni, salito a 42,8 nel 1900, 54,9 nel 1930 e 65,5 nel 1959. I figli per donna sono 1,25, siamo quindi ben al di sotto della soglia di ricambio generazionale di 2,1; i matrimoni vedono una netta prevalenza del rito civile (71,1), mentre le unioni civili sono 1.539. Nel 2021 le unioni matrimoniali hanno segnato un importante balzo in avanti rispetto all’anno prima, con ben 179mila matrimoni (erano stati 97mila nel 2020 e 184mila nel 2019). La storia demografica italiano ha conosciuto, dai tempi dell’unificazione, fasi storiche molto diversificate. Nel 1861 il contesto economico e sociale era molto differente da quello attuale, caratterizzato da un’elevata natalità e mortalità (anche infantile) che produceva un risultato molto diverso da quello contemporaneo: circa un terzo degli italiani aveva meno di 15 anni, gli ultrasessantacinquenni erano appena il 5 per cento. Il dato si rifletteva sulla popolazione in età attiva per il lavoro, che superava il 60 per cento (allora lavoravano anche i bambini); il dato attuale è in netta controtendenza: oggi i cittadini in età abile al lavoro sono circa il 59 per cento, ma secondo alcune proiezioni – per via dell’invecchiamento della popolazione e della bassissima natalità – il dato potrebbe calare al 48,4 già nel 2050. Operando un raffronto col mondo contemporaneo, potremmo dire che la realtà demografica dell’Italia postunitaria somigliava molto, per indici e tendenze, ai cosiddetti paesi del terzo mondo, specie dell’Africa subsahariana, che ancora oggi sono caratterizzati da un’elevata natalità e mortalità e ridotta aspettativa di vita, dovuta a condizioni igienico sanitarie assai precarie e ad un’economia di sussistenza, ancora ispirata all’idea dei figli come “braccia per i campi”. Nell’evoluzione demografica italiana, però, hanno pesato anche altri fattori. Tra gli ultimi decenni dell’Ottocento e i primi del Novecento un fenomeno che ha avuto riflessi molto importanti è stata l’emigrazione. Tra il 1861 e il 1985 è stato stimato che siano stati 30 milioni i connazionali emigrati all’estero, specialmente nelle Americhe e, in particolare nel secondo Dopoguerra, in Europa del nord (p. es. Francia, Germania e Belgio). Le ragioni di questi flussi sono ben conosciute: la ricerca di migliori condizioni di vita e lavoro, specie da parte di coloro che abitavano nelle aree più disagiate o prive di opportunità. Il regime fascista disincentivò le migrazioni, sia interne che internazionali. Durante il regime, però, furono numerosi gli italiani che andarono a vivere nelle colonie africane, come Libia e Africa Orientale Italiana. Il fascismo promosse la politica ruralista e natalista (ispirata allo slogan “il numero è potenza”), per cui furono favoriti tanto i movimenti verso le campagne (e le cosiddette città nuove), che le nascite, ricorrendo a programmi di assistenza e incentivi economici e onorifici per le madri più prolifiche e le famiglie più numerose. In realtà, nonostante la propaganda ufficiale, non si arrestò mai il flusso verso i centri urbani, che si tentò di disincentivare con una serie di misure restrittive: per esempio, nel 1939 entrò in vigore una legge che, salvo comprovate ragioni, vietava il trasferimento nelle città con popolazione superiore ai 25.000 abitanti, che si accompagnava ad altri provvedimenti che ostacolavano la mobilità collettiva. La politica natalista parve dare i suoi frutti: 7,8 milioni di italiani in più furono registrati tra il 1922 e il 1945, ma l’obiettivo del regime (70 milioni entro il 1960) non venne mai raggiunto per le note vicende storiche; nel ventennio la popolazione italiana, ad ogni modo, passava da 38,19 a 44,94 milioni. Caduto il regime e finita la guerra, in particolare tra il 1946 e il 1964, si registrò un consistente aumento delle nascite (il cd. baby boom) e – a partire dalla metà degli anni Cinquanta – a un grande spostamento di popolazione da sud a nord, in particolare verso il triangolo industriale Milano, Torino e Genova; i trasferimenti, in pieno boom economico e della grande industrializzazione, era dovuti prevalentemente a ragioni lavorative. Per quanto con numeri più contenuti, la tendenza alla migrazione verso il centro nord continua ancora a interessare il nostro paese: basti ricordare che delle venti province che negli ultimi anni hanno registrato incrementi nel numero dei residenti, quasi tutte si collocano in questa parte del paese; lo stesso dicasi per gli oltre 5 milioni di migranti stranieri, che si concentrano quasi sempre (circa l’80 per cento) nelle regioni del nord e del centro. Tali dinamiche, originate quasi sempre da fattori economici e occupazionali, producono pensanti conseguenze demografiche nelle aree “abbandonate” dai residenti, dove si verificano fenomeni di spopolamento (specie delle zone interne) e di invecchiamento degli abitanti rimasti. E qui veniamo ad un altro punto importante della questione demografica: il rapporto tra nascite e decessi e l’invecchiamento della popolazione italiana. Se nei primi anni del dopoguerra lo sviluppo economico e industriale, il baby boom e una società ancorata su valori tradizionali fecero registrare ancora saldi naturali (differenziale tra nati e morti) molto positivi (366.000 unità nel 1953, 526.000 nel 1964), a partire dalla metà degli anni Sessanta il trend si invertì ed inizio un progressivo calo. Questo fenomeno – contraddistinto da una diminuzione delle nascite e dall’invecchiamento della popolazione, per via dell’allungamento della speranza di vita – caratterizza le società più evolute e viene chiamato dagli studiosi “transizione demografica”. Fu nella seconda metà degli anni Settanta che il tasso di natalità scese per la prima volta al di sotto del tasso di rimpiazzo (2,1 figli per donna), avviandosi inesorabilmente verso la “crescita zero” (in pratica nati e morti si equivalevano). Il primo differenziale negativo tra nati e morti, invece, si registrò nel 1993; due anni dopo si toccò la soglia critica di 1,19 figli per donna. Nonostante alcuni timidi segnali di ripresa, il tasso di natalità italiano resta ancora oggi tra i più bassi del mondo: 1,46 per donna nel 2010, 1,34 nel 2016 (anno particolarmente negativo, con un calo percentuale del 2,4 rispetto a quello precedente), poco più di 420 mila i nati nel 2019, fino al minimo storico di 1,25 del 2021. In aumento anche l’età del concepimento, che si attesta su una fascia media di 32-33 anni, riducendo ulteriormente la natalità. Se nel ventennio 1981/2001 la popolazione italiana è rimasta sostanzialmente stabile, a partire dai primi anni del nuovo millennio è stato solo grazie ai massicci flussi migratori – 3.124.000, con una media di 446.000 persone all’anno, coloro che sono arrivati in Italia tra il 2002 e il 2008 – se il numero dei residenti nel nostro paese ha continuato ad attestarsi intorno ai 60 milioni; secondo alcune stime, senza l’apporto degli stranieri da inizio secolo si sarebbero perse circa 1,3 milioni di persone. Ciò è stato possibile anche e soprattutto a causa del maggior tasso di fertilità delle donne immigrate (per esempio, nel 2012 le straniere residenti in Italia contavano una media di 2,37 figli, contro l’1,29 delle nostre connazionali); ricordiamo, però, che negli ultimi anni anche il dato delle migranti è in calo. Sul fronte migrazioni, un passaggio storico importante, che segnò il passaggio del nostro paese da paesi di emigrazione a nazione di immigrazione, si verificò agli inizi degli anni Novanta, quando per la prima volta i migranti superarono i connazionali che andavano all’estero. Questo, però, non significa che si sia arrestata l’emigrazione italiana. Nel 2015 si è assistito ad un importante calo dei residenti (139mila unità) e dal 2014 in poi la popolazione residente è scesa di 677mila cittadini (nel solo 2018 sono stati in 157mila a lasciare il Paese); in pratica, giusto per intenderci, è come se fosse sparita l’intera città di Palermo. I flussi migratori, dopo l’interruzione nella fase più acuta della pandemia, sono ripresi: ad attrarre gli stranieri – specie quelli provenienti da Africa e Asia – sono le migliori condizioni di vita e lavoro, mentre dopo la Brexit e la decisione del Regno Unito di contenere gli ingressi, i flussi migratori si sono diretti verso altre nazioni europee (compreso il nostro paese). Per fornire alcuni numeri, il saldo migratorio netto con l’estero sale nel 2021 a 2,7 per mille abitanti, in netta risalita rispetto al 1,5 per mille del 2020, risultando più alto anche del 2019 (2,6 per mille). La fine della pandemia ha favorito anche la ripresa dei movimenti interni, che nel 2021 hanno interessato 1,4 milioni di persone, nella maggior parte dei casi a discapito del Mezzogiorno; i valori, nonostante la netta ripresa, risultano sempre inferiori al periodo pre-pandemico. Come attestato in alcune analisi congiunte operate da ISTAT e Ministero dell’Economia, anche le crisi economiche sortiscono importanti effetti sulle dinamiche demografiche. Tra i riscontri più significativi, la diretta proporzionalità tra l’aumento dell’indice di povertà relativa e il calo delle nascite registrato tra il 2008 (anno di inizio della recessione mondiale) e il 2017. Abbiamo fin qui parlato di nascite, movimenti di popolazione e invecchiamento, passeremo ora ad occuparci dei dati sulla mortalità. Storicamente i picchi più negativi si sono toccati nel nostro Paese in occasione di epidemie o guerre: nel 1867 per il colera, tra il 1915 e il 1918 a causa della Prima guerra mondiale e dell’epidemia di influenza spagnola, negli anni della Seconda guerra mondiale e, di recente, con le influenze asiatica (fine anni Cinquanta) e nel 2020 con la pandemia da Covid-19. Nel 2021 ci sono stati complessivamente 709 mila decessi, con un calo percentuale del 4,2 rispetto al 2020; 59mila decessi del 2021 sono stati imputati a mortalità da e con Covid-19 (nel 2020 era stati oltre 77mila). Come scrive l’ISTAT nel report ufficiale del 2021: “Tale conteggio, che complessivamente dà luogo a un eccesso di mortalità pari a 93 mila unità nel corso del 2020, lo si evince ipotizzando rischi di morte costanti pari a quelli osservati nel 2019 (647 mila decessi attesi rispetto a 740 mila rilevati)”. Come noto, nel 2020 si è registrato il tasso di mortalità più alto del dopoguerra, con 100.526 morti in più rispetto alla media del quadriennio precedente. Occorre, però, differenziare l’incidenza del dato per fasce di età, visto che in quelle 0/14 e 25/34 si registrano addirittura dei cali nella mortalità (rispettivamente del 15,8 e 12,3 per cento), con incrementi in quella 15/24 (+4,1) e numeri crescenti per gli over 50, in particolare per gli over 80, specie in presenza di altre patologie. L’indice di letalità da Covid-19, in assenza di altre patologie, è di poco superiore allo zero negli under 50 (scende allo 0,01 per gli under 40), mentre l’85 per cento dei decessi riguarda gli over 70, toccando il 25 per cento per i novantenni. Chiaramente ha inciso fortemente la presenza di molti anziani, a causa dell’invecchiamento della popolazione, senza dimenticare i pesanti tagli ai servizi sociosanitari dell’ultimo decennio (- 25 miliardi di euro nel quinquennio 2010/2015; 46mila unità in meno nel personale sanitario; 30 per cento di posti letto in meno negli ospedali rispetto al 2000, un terzo quelli tagliati in terapia intensiva rispetto agli anni Ottanta). Il 2020, inoltre, ha registrato un calo dell’aspettativa di vita di 1,2 anni rispetto al 2019, assieme a un consistente calo delle nascite (403 mila neonati) e un dimezzamento dei flussi migratori (calati del 12 per cento sul versante della mobilità interna). Il saldo naturale (differenza tra nati e morti) segna nel 2021 un -309mila (-335 mila nel 2020); restiamo, insomma, ben lontani dalla condizione di equilibrio toccata per l’ultima volta nel 2006, che neppure i flussi migratori, ripresi dopo il blocco dovuto alla pandemia, hanno consentito di recuperare. La pandemia ha avuto ripercussioni anche su altri numeri. Così se nel 2019 ci furono complessivamente 420 mila nascite, nel 2021, complici le restrizioni pandemiche e il blocco dei matrimoni, si è scesi a 399 mila. Volendo rivolgere uno sguardo al futuro, sono decisamente pessimistiche le previsioni stilate per il nostro paese dalle Nazioni Unite nel 2017: si parlava di 53,3 milioni di abitanti nel 2065, 49,6 milioni nel 2100; andrà ancora peggio per l’Institute for Health Metrics and Evaluation di Washington, secondo il quale la popolazione si ridurrà a 28 milioni nel 2100. Le stime fatte dall’ISTAT parlano di 54,1 milioni nel 2050 e 47,6 milioni nel 2070, vale a dire 12 milioni di persone in meno in appena mezzo secolo. Non meno confortanti le proiezioni sull’andamento delle nascite: entro il 2040 più di una famiglia su cinque non avrà figli; già oggi aumentano i single (8,6 milioni), che diverranno 10,3 milioni nel 2040; il 2048 potrebbe essere l’anno in cui i decessi saranno il doppio rispetto alle nascite. Non confortano le previsioni circa un aumento del tasso di fecondità: anche se si arrivasse a 1,55 figli per donna entro il 2070, questo non basterebbe per compensare calo demografico e tasso d’invecchiamento. Una cosa è certa. Come rilevato nel 2012 dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), i paesi cosiddetti sviluppati (a cominciare dal nostro) vanno verso un raddoppio degli anziani entro il 2050 (dal 11 al 22 per cento), con gli anziani (over 65) più numerosi dei bambini (in Italia si ipotizza a metà secolo un quasi 36 per cento di anziani). Non vanno meglio gli squilibri generazionali, vale a dire l’indice di dipendenza degli anziani (vale a dire il livello di supporto disponibile per le persone over 65 da parte dei cittadini di età compresa tra 15 e 64 anni), arrivato al 32 per cento, che potrebbe toccare il 53 per cento entro i prossimi trent’anni; il dato italiano è ancora peggiore: siamo già vicini al 40, con la prospettiva di toccare il 75 entro il 2050. I riflessi di questa nuova situazione demografica saranno importantissimi sotto il profilo socioeconomico e sanitario: le malattie cronico degenerative (tipiche della terza età) tenderanno a superare quelle infettive e carenziali, assieme ad un aumento delle spese per l’assistenza personale e sanitaria e degli oneri previdenziali; tali oneri, oltretutto, rischiano di non essere sostenibili finanziariamente a causa del ridursi della popolazione in età attiva. Nessuno discute i progressi della scienza e della medicina che hanno consentito il prolungamento della vita e l’innalzamento della sua qualità, per lo meno nelle nazioni più “fortunate”, ma occorre comprendere che senza un’adeguata programmazione delle politiche sanitarie e previdenziali, puntando sulla ricerca, sugli interventi organizzativi e sulle strutture (compresa l’assistenza alle famiglie e alla genitorialità) si rischia un quadro drammatico. Non aiuta la precarizzazione del mercato del lavoro, che anche nel nostro paese ha visto assottigliarsi (o sparire del tutto) diritti e garanzie collegate al cosiddetto “posto fisso”, compromettendo – per lo meno ritardando fortemente – la formazione delle famiglie e/o la messa al mondo dei figli. In altre parole, in assenza di politiche lungimiranti il rischio – per nulla ipotetico – sarebbe quello di compromettere molti dei grandi traguardi raggiunti negli ultimi cento anni. L’Italia è il paese messo peggio a livello europeo per indici di natalità e tasso d’invecchiamento della popolazione (il secondo al mondo dopo il Giappone), ma trattandosi di una tendenza comune a tutto il mondo sviluppato, è auspicabile che siano messe in atto tutte quelle scelte che consentano di affrontare una realtà alla quale già oggi sappiamo che stiamo andando incontro; e questo prima che sia troppo tardi, per gli anziani (e non solo) di oggi e di domani.
di Paolo Arigotti