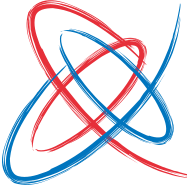L’autorità garante per le comunicazioni (Agcom) ha reso noti i dati relativi ai primi nove mesi del 2023 inerenti al settore delle Comunicazioni. Per quanto concerne le televisioni il calo degli ascolti medi giornalieri e quello riferito alla fascia del cosiddetto prime time (la prima serata dalle 20,30 alle 22,30), si attesta su valori negativi, rispettivamente, del 2,5 e 2,8 per cento, confermando la tendenza che dal 2019 ha fatto segnare una riduzione degli ascolti stimata in valori percentuali superiori al dieci per cento. Le ragioni del calo possono essere ricondotte sia a fattori anagrafici, che di altra natura. Se il pubblico cosiddetto anziano (gli over 65 per intenderci) è ancora oggi il maggiore “consumatore” dei prodotti televisivi tradizionali, è altrettanto vero che le altre “classi” anagrafiche – a cominciare dai giovani – si rivolgono sempre di più verso il web e i social, non solo per l’intrattenimento, ma anche per l’informazione. Ma non è questa l’unica causa. I format proposti, specie negli ultimi anni, sono estremamente ripetitivi: se determinate trasmissioni continuano a far registrare importanti ascolti, cui fanno da pendant gli introiti pubblicitari, è altrettanto vero che una tendenza come quella descritta dall’Agcom dovrebbe suscitare perlomeno qualche riflessione tra coloro che rivestono ruoli decisionali nella programmazione e nella scelta dei contenuti (e dei conduttori); non sarebbe male, ad esempio, un potenziamento e una diversificazione dei temi di approfondimento in un paese come il nostro, dove ancora oggi la percentuale del PIL destinata alla ricerca si attesta su un miserevole 1,5 per cento. E non va meglio per i telegiornali, che tra il 2019 e il 2023, hanno perso milioni di telespettatori, con cali stimati intorno al 10 per cento. E se la televisione piange, la carta stampata non ride. Se ancora nel 2007 circa 2/3 degli italiani leggeva almeno un quotidiano, oggi la percentuale si è ridotta a un terzo, calo che pure le testate on line non riescono a contenere, nonostante il fenomeno del cosiddetto TAL (Traffic Assignement Letter), accordi di cessione del traffico che consentono ad alcune testate di intestarsi click e visualizzazioni riferite ad altri portali. Per tutti i dati facciamo rinvio a un approfondimento recentemente uscito con L’Indipendente (www.lindipendente.online/2023/12/29/i-media-mainstream-sono-ormai-una-tigre-di-carta/). Non va meglio per le principali piattaforme on line (una per tutte, Netflix) che stanno registrando cali negli ascolti e negli abbonamenti, difficilmente imputabili solo a ragioni economiche. Una delle pecche che affliggono molti dei contenuti descritti – e qui ci riferiamo sia all’informazione, che alla cultura, che talvolta trovano un punto d’incontro nel cosiddetto “infotainment” – sono certamente gli scarsi investimenti. Il problema è che se è indubbio che riproporre “pietanze riscaldate” comporti minore impegno in termini di risorse, è difficile pensare che a lungo andare non si ingeneri l’effetto “stanchezza”. E aprendo il delicato capitolo dell’informazione emerge pure un altro aspetto, per nulla secondario. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un’inarrestabile spirale allarmistica ed emergenziale – pensiamo a quella terroristica, economica, pandemica, bellica, climatica, e via dicendo – che a lungo andare sta producendo nelle persone, per lo meno quelle munite di pensiero critico (auspicabilmente in numero crescente), la percezione di una distanza, a tratti incolmabile, tra la narrazione veicolata dai media tradizionali e la realtà, che si presenta molto più complessa e articolata di quella ripresa dagli organi d’informazione, che tentano, non sempre con successo, di operare una semplificazione a tratti inaccettabile. La stessa tesi, che qualcuno ancora oggi tenta di far passare, secondo la quale chiunque sostenga posizioni e/o opinioni “diverse” debba essere esposto al pubblico ludibrio (magari con etichette coniate all’occorrenza, ovviamente in senso dispregiativo), e/o indicato come latore di “fake news”, a nostro avviso ha fatto il suo tempo, e continuare a riproporla rischia solo di allargare un vulnus sempre più evidente. Sia chiaro, siamo i primi a riconoscere che esistono le “bufale” e che ne circolino tante, non solo in rete, ma da questo a catalogare come tale ogni narrazione che si discosti da quella “ufficiale”, specie quando proveniente da esperti di comprovata competenza, ce ne corre. Non riflettere su questi elementi potrà solo far precipitare sempre di più indici di gradimento e di ascolto. Una soluzione potrebbe essere quella di cominciare a introdurre dei cambiamenti, magari mandando a godersi il meritato riposo coloro, ai quali auguriamo naturalmente lunga vita e prosperità, che si mettano di traverso rispetto a un’esigenza di cambiamento sempre più avvertita da tutti quelli che non chiudono, o fanno finta di farlo, gli occhi per non vederla. L’Italia si colloca, nonostante il recupero rispetto al 2022 (quando eravamo alla posizione 58) al 41^ posto per libertà di stampa a livello planetario, ragion per cui qualche domanda sarebbe veramente il caso di iniziare a porsela, invece che lanciare “crociate” contro la – vera o presunta – disinformazione che rischiano solo di accrescere il divario tra chi produce informazione, e chi invece fa un altro mestiere.
di Paolo Arigotti