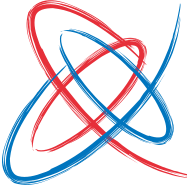Abbiamo già parlato della storia e della geopolitica della Cina e di Taiwan – Formosa, ragion per cui oggi ci occuperemo, pertanto, delle novità e degli sviluppi delle ultime settimane, innescati dalla visita a Taipei, ai primi di agosto, della presidente (Speaker) della Camera dei rappresentanti degli USA, Nancy Pelosi. La terza carica istituzionale per importanza degli Stati Uniti si è trattenuta poco meno di 24 ore, e durante il breve soggiorno le è stata persino conferita la più alta onorificenza civile di Taiwan: l’Ordine della Nuova Propizia. Diciamo subito che non è stata la prima volta di un presidente della Camera americano a Taiwan. Nel 1997 l’allora “omologo” repubblicano della Pelosi, Newt Gingrich, si era recato nell’isola, ma come giustamente ha fatto notare Victor Gao, analista politico cinese (ed ex interprete dello scomparso leader storico Deng Xiaoping) il contesto internazionale è molto cambiato rispetto ad allora. Le crescenti tensioni, in particolare nel contesto dell’Indo pacifico, hanno modificato i rapporti tra le grandi potenze, leggi tra Pechino e Washington. Lo stesso Gao ha detto che “Le esercitazioni cinesi hanno dimostrato che nessun intervento militare esterno sarà mai permesso”, con un chiaro riferimento alle reazioni di Pechino dopo una visita assai sgradita (scusate l’eufemismo), come la diplomazia della Repubblica Popolare aveva chiaramente lasciato intendere – per il tramite dei canali ufficiali – ancora prima che avesse luogo. Oltretutto, tra le diverse questioni al centro dei colloqui tra la Pelosi e i governanti taiwanesi figurano diritti umani e commercio, il che ha contribuito ad irritare ulteriormente Pechino, che li ha interpretati – e probabilmente lo erano – come delle “frecciatine” dirette nei suoi confronti. Gli stessi analisti cinesi, riferendosi alla visita del ’97 di Gingrich, hanno fatto notare che questi apparteneva a un partito politico (quello repubblicano) diverso rispetto a quello del presidente in carica (Bill Clinton), ragion per cui il viaggio della Pelosi non potrebbe essere letto (e tantomeno giustificato) con eventuali contrasti politici tra Congresso e Presidente, entrambi espressione del partito democratico. Aggiungiamo, ad onor del vero, che sia l’Amministrazione (compreso il Pentagono), che diversi analisti avevano sconsigliato questo viaggio, che la Speaker ha egualmente deciso di compiere, nel quadro di un tour che ha toccato Singapore, Corea del Sud, Giappone e Malesia. Le ragioni del disappunto della Cina popolare sono risapute: Pechino considera Taiwan (e le altre isole amministrate da Taipei) come parte integrante del proprio territorio, alla stregua di una provincia “ribelle”, come tale destinata – prima o poi – a tornare sotto il controllo della Cina continentale. Il presidente Xi Jinping lo ha ribadito più volte, da ultimo in occasione delle celebrazioni per la nascita della Repubblica popolare, fissando al 2049 il termine ultimo per la “riunificazione”. Il concetto è stato espresso anche nel recente “libro bianco” (una sorta di documento politico programmatico), intitolato “The Taiwan Question and China’s Reunification in the New Era”, dove viene ripetuto come quello di Pechino è l’unico governo legittimo dell’intera Cina, senza alcuno spazio tollerabile per ingerenze esterne, aggiungendo – particolare di non poco conto – che se l’obiettivo resta la riunificazione pacifica, “… non rinunceremo all’uso della forza e ci riserviamo la possibilità di prendere tutte le misure necessarie” contro le “interferenze esterne e le attività separatiste”. Un avvertimento molto chiaro, che lascia pochi margini a dubbi di sorta. Alla visita “lampo” della Pelosi, sempre nel corso del mese di agosto, hanno fatto seguito quelle di diverse delegazioni di politici e uomini di affari americani, compreso il segretario di Stato Mike Pompeo, tornato a Taipei dopo circa sei mesi; sono in corso di svolgimento o già annunciati ulteriori arrivi di missioni giapponesi, canadesi e tedesche, che di sicuro non contribuiranno a rasserenare il clima. Per restare in Italia, si vocifera di simpatie pro Taiwan della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, premier in pectore in caso di vittoria elettorale del centrodestra alle elezioni del 25 settembre, mentre ricordiamo la recente interruzione dei rapporti tra l’agenzia Ansa e la cinese Xinhua (che ha stabilito, però, una partnership con la Nova), dovuta, secondo Giorgio Cuscito, al contrasto agli interessi cinesi voluto e avviato sotto il Governo presieduto da Mario Draghi. Nonostante i timori iniziali, la risposta di Pechino – vista la situazione – non è stata bellicosa (e aggiungiamo, per fortuna!). Naturalmente si sono levate note di protesta ufficiali, precedute dalla minaccia (non concretizzatasi) di impedire l’arrivo nell’isola del volo della Pelosi (e della sua scorta), ma questo non significa che Pechino abbia lasciato correre. Nei giorni immediatamente successivi, dopo la ripartenza della Speaker, le forze armate della Repubblica Popolare (esercito popolare di liberazione, marina e aeronautica) hanno dato avvio a una serie di esercitazioni e incursioni, che hanno interessato, tra le altre, le zone al largo dell’isola di Pingtan, nella provincia del Fujian, a poco più di cento chilometri dalle coste taiwanesi. E, per dirla con le parole di un famoso e amato presentatore televisivo, non finisce qui, visto che le operazioni militari, anche se ridotte nella loro frequenza e importanza, sono proseguite praticamente per tutto il mese. L’analista Giorgio Cuscito, collaboratore di Limes e profondo conoscitore delle questioni cinesi, ritiene che per ora di “riunificazione” (secondo la terminologia usata dal leader cinese) non se ne parla – pacifica o meno che essa sia -, a causa di una serie di fattori (come la crisi pandemica, gli assetti politici interni legati all’imminente congresso del partito comunista cinese, le difficoltà economiche), anche se resta il fatto che la Cina con le sue azioni militari “mirate” ha oltrepassato per la prima volta la cosiddetta linea mediana nello stretto taiwanese, che aveva sinora costituito una sorta di confine non ufficiale tra le due Cine, fissato unilateralmente dagli USA nel 1955; si tratta di un segnale (per ora solo politico) di grande importanza, volto a lanciare un messaggio altrettanto forte: Pechino non riconosce detta linea di confine, e si riserva di attraversarla senza colpo ferire. La portavoce del ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che “ … la Cina di oggi non è la Cina di 120 anni fa, e pertanto non accetta di “essere trattata come l’Iraq, la Siria o l’Afghanistan”: nulla da aggiungere! Sappiamo bene che la Cina non riconosce la sovranità e l’indipendenza dell’isola, ma in questo senso si trova in buona compagnia, visto che detto riconoscimento è negato dalla quasi totalità delle nazioni del pianeta, compresi gli Stati Uniti, che – ne abbiamo già parlato – hanno sposato la tesi della “unica Cina” (quella popolare). Riguardo Taiwan, tuttavia, resta in vigore, almeno per ora, la cosiddetta “dottrina dell’ambiguità”: l’isola, di fatto, è e resta uno stato sovrano, il cui maggior interscambio commerciale, al proposito di ambiguità, avviene proprio con la Repubblica Popolare, che nel 2021 si è confermato primo partner, con un record della bilancia commerciale a favore di Taipei. Le reazioni di Pechino non si sono limitate alle note diplomatiche e alle iniziative militari; vanno ricordate le oltre 600 incursioni aeree registrate nel corso dell’ultimo mese, compresi i droni che hanno sorvolato diverse isole amministrate da Taipei– come le Kinmen, Lieyu, Dadan e Caoyu – e che in taluni casi hanno visto una risposta da parte delle forze armate taiwanesi, che ne hanno abbattuto uno nei pressi dell’isola di Kinmen, un avamposto che si trova a circa tre chilometri dalle coste cinesi, ribattezzata con una chiara allusione la Crimea cinese. Il governo di Pechino, inoltre, ha deciso la sospensione degli incontri e colloqui militari con gli americani, assieme ad una serie di ritorsioni commerciali contro Taipei, come il blocco delle importazioni di alcuni prodotti taiwanesi (come agrumi, pesce e biscotti) e dell’export di sabbia, materia prima indispensabile per la produzione dei microchip (che da soli fanno circa il 12 per cento del PIL isolano). Non è stato, invece, disposto il temuto blocco dei porti isolani, che Pechino sarebbe perfettamente in grado di attuare, visto che gli scali maggiori affacciano proprio sulla Cina continentale, ma qui subentrano ragioni di ordine geopolitico visto che Taipei (primo produttore mondiale) rifornisce coi suoi microchip il resto del globo, Cina inclusa. A tal proposito, ricordiamo che ad avviso di alcuni analisti non è affatto detto che se la Repubblica Popolare s’impossessasse (con le buone o con le cattive) dell’isola, metterebbe automaticamente le mani anche su questa importante risorsa. Sul fronte interno, i taiwanesi – stando ai sondaggi – non si sono detti intimoriti dalle azioni messe in atto dal potente vicino, ma il governo di Taipei ha egualmente stanziato un aumento della spesa militare del 14 per cento. Di certo, vista l’esperienza di altri territori di recente acquisizione (Hong Kong e Macao), la prospettiva di finire sotto il controllo di Pechino non è appetibile, come non possono essere prese per oro colato certe promesse ispirate al principio “un paese, due sistemi”, che nella ex colonia britannica – dove recentemente sono stati messi sotto processo decine di dissidenti – non ha mai ricevuto un’applicazione particolarmente favorevole agli abitanti. Ad enfatizzare certi timori, il fatto che nelle ultime versioni ufficiali dei documenti cinesi dedicati alla “riunificazione” scompaiono tutti i riferimenti alle decisioni condivise con i taiwanesi. Qualcuno ha fatto un parallelismo tra Taiwan e la situazione ucraina – già nel 2021 The Economist definiva l’isola il luogo più pericoloso della Terra – valutandola come un terreno di scontro potenziale, a lungo una sorta di linea di confine tra le due superpotenze (e le rispettive marine militari), ma questa lettura è stata respinta dai cinesi che già a marzo scorso, per bocca del portavoce del ministero della Difesa, rigettarono ogni parallelismo, ribadendo che “La questione di Taiwan è un affare interno della Cina che non tollera alcuna interferenza straniera”. È chiaro che nei timori di molti osservatori si ravvisa, qualora si concretizzasse l’ipotesi peggiore, il classico casus belli tra le due più maggiori potenze politiche, economiche e nucleari, ma che il fatto si verifichi è un altro paio di maniche. Gli Stati Uniti continuano, nei fatti, a difendere e tutelare Taiwan, pur senza riconoscerne formalmente il governo: una serie di accordi, tra i quali il Taiwan Relations Act del 1979 e il recentissimo Taiwan Policy Act del 2022, contengono una serie di intese di ordine economico e militare, senza dimenticare che Joe Biden ha recentemente ribadito la volontà di collaborazione (compreso l’addestramento militare) con Taipei, assieme all’intenzione di vendere nuovi armamenti all’isola per un valore di 1,1 miliardi di dollari (decisione che dovrà essere ratificata dal Congresso USA). Inoltre, Washington, col chiaro intento di porre un argine all’espansione cinese nel Pacifico, ha indetto per la fine di settembre un summit con diverse isole-stato dell’area, invitando anche le Isole Salomone. Non ci attarderemo sulle modalità concrete dell’eventuale invasione cinese dell’isola, ammesso che questa sia un’ipotesi realistica, lasciando la questione agli esperti di strategia militare; ci limitiamo a riportare l’opinione secondo cui l’intenzione di Pechino sarebbe di temporeggiare, sperando in un’annessione pacifica, senza assumere nessuna iniziativa bellica fin quando non verrà raggiunto l’obiettivo di un potenziamento militare (a cominciare dalla marina), programmato per il 2035. Un’altra strategia che, in astratto, sarebbe percorribile per i cinesi, senza colpo ferire (o quasi) sarebbe quella del blocco totale o parziale dell’isola, realizzando un assedio reso agevole, come dicevamo, dal fatto che i porti più importanti affacciano sul lato continentale, ma la valenza economica e commerciale dell’isola (vedi discorso semiconduttori) renderebbe ostica questa strada. Anche fare pressioni per il tramite delle Nazioni Unite (dove la Cina è unico governo riconosciuto e membro permanente del Consiglio di sicurezza) e/o ricorrere al diritto internazionale generalmente riconosciuto, non necessariamente darebbe gli esiti sperati, visto il contrasto che sicuramente opporrebbero gli americani. A questo punto, FORSE, ma questa prendetela come una mera opinione personale degli autori, l’unica via che resterebbe sarebbe quella negoziale e del dialogo, atteso che – come forse il conflitto ucraino potrebbe insegnare – la logica dello scontro, diretto o per procura, non porta mai a risultati particolarmente brillanti. Dedichiamo a questo punto qualche cenno alle reazioni della restante comunità internazionale. La Cina, sappiamo anche questo, è la “manifattura del mondo” e un importantissimo partner commerciale e tecnologico per moltissimi paesi, i quali difficilmente metterebbero da parte i loro interessi per difendere l’indipendenza e la sovranità taiwanese, senza contare che in tanti non avrebbero la forza e/o l’interesse militare a prendere parte ad una guerra contro la Cina. Prendiamo il Giappone che, nonostante l’intenzione di aumentare gli investimenti nella difesa (p. es. nelle dotazioni missilistiche), non dispone delle risorse necessarie, ed è impegnato (e preoccupato) con altri attori internazionali (come la Russia, vedi Vostok 2022). Lo stesso discorso vale per la Corea del sud, che guarda al vicino del nord. Qualche maligno ha visto nella visita della Pelosi una mossa di Washington per ricompattare i proprio alleati in funzione anticinese, ma che la mossa (anche se fosse) riesca è un altro discorso. A noi pare che Taiwan, Stati Uniti a parte, non potrebbe contare su sostegni importanti tra i suoi vicini. La Russia ha già manifestato solidarietà a Pechino sulla questione in virtù della partnership strategica, mentre i paesi sudamericani si terrebbero presumibilmente a debita distanza (come hanno fatto col conflitto ucraino), mentre altri attori, come gli stati africani e mediorientali, darebbero probabilmente maggior peso ai rapporti economici con Pechino. Gli europei, a loro volta, potrebbero considerare quello dell’Indo pacifico uno scenario geograficamente molto distante, e le preoccupazioni per il prossimo inverno (ad iniziare dagli approvvigionamenti energetici) sono decisamente molto più impellenti e prioritarie. Resterebbero l’Iran, che con ogni probabilità stringerà sempre più forti legami con la Cina, e l’India che finora si è tenuta in disparte, anche se Nuova Delhi ha recentemente accusato Pechino di voler militarizzare lo stretto (non dimentichiamo che tra i due giganti asiatici non corre buon sangue, come per le regioni di confine o per lo Sri Lanka). E poi c’è l’Australia – avamposto anglofono nell’Indo pacifico – che pur investendo nella nuova flotta di sottomarini nucleari (Aukus) non necessariamente sarebbe in grado di competere con la Cina, mentre i paesi dell’Asean costituiscono un insieme molto variegato, all’interno del quale (è il caso della Cambogia) esistono importanti rapporti militari con la Cina popolare; l’unica eccezione potrebbero essere le Filippine di Marcos, il solo stato dell’area a manifestare una qualche disponibilità, offrendo cooperazione in caso di crisi, specie dopo il durissimo comunicato di Pechino secondo cui “con il pretesto della libertà di navigazione, le navi da guerra americane mettono in mostra la loro forza: non si tratta di una promessa di ‘libertà e di apertura’, ma di una provocazione che cerca di scatenarsi sulla libertà e di un deliberato sabotaggio della pace e della stabilità regionale” (un chiaro riferimento al provocatorio attraversamento dello stretto di Taiwan da parte di alcune navi militari statunitensi, dileggiate come “vecchie” dai media di Pechino). Lorenzo Lamperti, analista italiano che vive a Formosa, ritiene che andrebbe “… sottolineato anche quello che NON è successo. Nonostante le incursioni, non c’è stato il temuto ingresso dei cinesi nelle acque territoriali taiwanesi o il sorvolo dell’isola principale di Taiwan, opzioni che Pechino (forse) si riserva per una futura escalation.” Beninteso, non sono le prime iniziative militari nei pressi della “provincia ribelle”: 380 si sono verificate nel 2020 e 746 sono state quelle del 2021, ma il fatto innovativo è che stavolta si sono concentrate in pochi giorni. E’ difficile, ora come ora, immaginare il futuro politico e lo status internazionale di Taiwan, tenuto conto che la questione è controversa perfino all’interno degli ambienti politici isolani: è vero che tutti i partiti difendono la sovranità nazionale, ma sono divisi tra chi sembra orientarsi (è il caso del Partito progressista democratico dell’attuale presidente Tsai Ing-wen) verso la tesi indipendentista tout court, una Repubblica di Taiwan internazionalmente riconosciuta, e coloro che invece sembrano voler restare ancorati al passato – è il caso del Kuomintang, oggi all’opposizione – più inclini alla logica del compromesso, salvaguardando l’autonomia de facto; qualcuno ne ha visto una conferma nella recente visita di una delegazione del partito nazionalista nella Cina continentale, mentre si avvicinano le prossime presidenziali (2024), nelle quali potrebbe trionfare l’attuale vice presidente William Lai, assai più radicale dell’attuale capo dello stato Tsai. Il nostro auspicio è che alla fine non abbia ragione il premier di Singapore, Lee Hsien-loong, che preannuncia come una “tempesta è in arrivo nella regione dell’Indo-Pacifico”. Occorre considerare, difatti, che se una simile prospettiva si concretizzasse, sarebbe difficile pensare che la tempesta coinvolgerebbe solo questa parte (strategica) del pianeta. Se pure fosse realistico – come sostiene tra gli altri l’analista geopolitico taiwanese Su Tzu-Yun – che la Cina non abbia al momento le capacità militari per invadere l’isola, devono essere ugualmente attenzionati gli scenari attuali e futuri: difficile affermare che la visita della Pelosi sia stata la causa della escalation, ma potrebbe comunque trasformarsi in un fattore d’innesco di potenziali piani d’invasione che esistono eccome, come ammette Chieh Chung, esperto militare di Taipei, nell’ambito di un think tank considerato vicino al Kuomintang. Il governo di Pechino vuole riservarsi in via esclusiva la comunicazione legata alla crisi nello stretto (la quarta in ordine di tempo), come comprovato dalla chiusura di alcuni blog ultranazionalisti e antioccidentali, mentre i cinesi si sono affrettati a ribadire che, nonostante la violazione dei patti su Taiwan da parte dell’America, la Cina non ricorrerà (per ora) alla forza. Nel frattempo, nonostante le provocazioni reciproche (le incursioni cinesi sono proseguite anche nei giorni scorsi, come il transito nelle navi americane), le tensioni sembrano sopirsi, o forse si è semplicemente ridotta l’attenzione dei media, in attesa di eventuali e ulteriori sviluppi. Il 5 settembre 2022 il filosofo Giorgio Agamben ha scritto, tra le altre cose, che “Le potenze che si battono non hanno infatti alcuna salvezza e alcuna verità da proporre: solo una continua, incombente minaccia di malattia e morte e l’odio e la guerra di ciascuno verso tutti. Sono, in questo senso, alla fine e l’atroce guerra civile planetaria che conducono è la forma della loro fine.” Come dargli torto?
di Paolo Arigotti