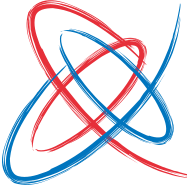Nella P.A. si sono susseguite normative non sempre perfettamente coordinate per la questione della parità (o della disparità) di genere inerenti vicende lavoristiche e pensionistiche dei lavoratori italiani, vicende che paradossalmente hanno trovato nuova linfa in seguito alla entrata in vigore della riforma Fornero.
In particolare, per le donne esistevano due specifici aspetti che debbono essere chiariti.
Il primo aspetto riguarda il normale e generale collocamento a riposo d’ufficio che doveva avvenire per tutti al raggiungimento del limite di età ordinamentale generalmente previsto per i 65 anni, tranne che per talune figure per le quali era fissato all’età di 60 anni (vedi ad esempio il personale infermieristico delle ASL o qualche regolamento organico di enti locali).
Tale limite divenne poi per tutti quello dei 65 anni per effetto della legge n° 903 del 9 dicembre 1977. Il limite di età regolamentare è quindi divenuto uguale per tutti senza differenza di genere, anche se necessariamente da raccordare con le norme pensionistiche.
Il secondo aspetto riguarda l’età pensionabile che per tutti i lavoratori seguiva pedissequamente l’età ordinamentale, salvo raccordarsi con le vicende della riforma Amato (D.lgs. n° 502/1992).
Per le donne, a prescindere dal limite di età previsto per il collocamento a riposo d’ufficio, l’età poteva facoltativamente essere fissata ad un limite non inferiore a 60 anni così come disposto a suo tempo dall’articolo 2, comma 21, della legge n° 335 del 8 agosto 1995; ne derivava che l’Amministrazione non poteva adottare il provvedimento di collocamento a riposo d’ufficio, ma la lavoratrice poteva dimettersi ottenendo tranquillamente la pensione di vecchiaia.
Poi, in attuazione di sentenza della Corte di Giustizia Europea la legge n° 102 del 3 agosto 2009 avviò il percorso di innalzamento dell’età pensionabile delle lavoratrici del settore pubblico a partire dal 2010, con l’obiettivo della parificazione agli uomini dal 2018.
L’ulteriore pressing della Commissione Europea ha poi portato alla emanazione dell’articolo 12, comma 12-sexies, del d. legge n° 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n° 122 del 30 luglio 2010, mediante il quale era stato introdotto l’innalzamento del limite di età a 65 anni a partire dal 1° gennaio 2012.
Prima ancora quindi della riforma Fornero, avevamo eliminato ogni differenza di genere nel settore pubblico, fermo restando che le lavoratrici che avessero già perfezionato preesistenti requisiti avrebbero potuto continuare ad accedere a pensione.
Sulle pensioni di anzianità (o anticipate) non avevamo nessun problema poiché i requisiti erano identici per tutti, così come uguali per tutti erano le condizioni, in cui avrebbe potuto verificarsi la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Ora paradossalmente il problema si ripresenta a partire dal 1° gennaio 2012 per effetto dell’ultimo intervento riformatore, con due situazioni diverse fra cessazione per vecchiaia e cessazione per risoluzione unilaterale.
Partiamo dalla risoluzione unilaterale poiché è quella di più semplice soluzione.
Nella sua originaria versione, il D.L. n° 112/2008, prevedeva la possibilità di applicazione che il lavoratore o la lavoratrice potessero far valere la “massima anzianità contributiva dei 40 anni”; il problema si è posto dal 2012, poiché da un lato non esiste più la “massima anzianità” e dall’altro la nuova pensione anticipata vede accedervi uomini e donne con requisiti diversi.
Finché è il lavoratore o la lavoratrice che si dimettono per accedere a tale pensione non esiste alcun problema (tutto al più è il lavoratore che potrebbe ritenersi discriminato poiché deve lavorare 1 anno in più), ma quando è l’amministrazione che licenzia il lavoratore ecco che emergono nuovamente le disparità di genere poiché a questo punto la lavoratrice potrebbe essere licenziata prima del lavoratore.
Non è secondario ricordare che su tale disparità si è già accesa l’attenzione della Commissione Europea che non ha ancora aperto una formale procedura di infrazione contro l’Italia, ma ha già chiesto che venga rimossa.
L’articolo 1, comma 5, del D.L. n° 90/2014 ha semplicemente ratificato detta situazione come ampiamente commentato dalla circolare n° 2/2015 di Funzione Pubblica.
Quella circolare ha però resa esplicita una giusta preoccupazione che si è tramutata in un suggerimento alle amministrazioni pubbliche.
Poiché la risoluzione deve essere motivata, è stato suggerito di adottare atti regolamentari contenenti i criteri applicativi, in presenza dei quali la motivazione non serve.
In tale contesto la Funzione Pubblica ha dato il seguente suggerimento: “nel definire i criteri le amministrazioni valuteranno se prevedere soluzioni di armonizzazione tra uomini e donne, riguardo al momento di adozione della risoluzione unilaterale del rapporto, al fine di scongiurare casi di discriminazione di genere in relazione al diverso requisito di anzianità contributiva richiesto.”
Tutto torna, quindi, in mano alle singole amministrazioni.
Peccato però che tale attenzione non sia stata manifestata, in ordine alla cessazione per limiti di età.
Da un lato la riforma Fornero ha esplicitamente ribadito, che restano fermi i limiti di età ordinamentali e il D.L. n° 101/2013 ha ulteriormente chiarito, che non sono assolutamente derogabili nei confronti di coloro che hanno acquisito “qualsiasi” diritto a pensione.
Dall’altro lato si è riaffermato il principio in base al quale coloro che hanno acquisito i requisiti per il diritto a pensione continuano ad accedervi in base alle preesistenti normative.
Siamo quindi di nuovo di fronte ad un aspetto positivo che consente a taluni di accedere a pensione prima rispetto ad altri, come accade per gli uomini che avevano già compiuto i 65 anni di età e maturato i 20 anni di contribuzione, ma anche alle donne che avevano già compiuto i 61 anni di età e maturato i 20 anni di contribuzione.
Per contro esiste il lato negativo, che oggi presenta la seguente situazione.
Prendiamo un lavoratore e una lavoratrice dipendenti pubblici che compiono al 31 ottobre 2021 i 65 anni di età, entrambi con circa 35 anni di contribuzione alle spalle.
Ebbene, al lavoratore non accade nulla poiché non aveva maturato alcun diritto a pensione, motivo per il quale continuerà a prestare attività lavorativa fino al compimento dei 66 anni e 10 mesi, per cui andrà in pensione al 31 agosto 2022 con 36 anni e 10 mesi di contribuzione.
La lavoratrice, invece, verrà collocata a riposo dal 1° novembre 2021, poiché aveva già maturato il diritto a pensione e otterrà una prestazione con 35 anni di contribuzione.
Di fronte a tale situazione stupisce che il Dipartimento della Funzione Pubblica rimanga in silenzio e non dia alle amministrazioni pubbliche indicazioni operative, che evitino il contenzioso.
Penso che uno dei motivi fondamentali che hanno generato quelle norme e quelle interpretazioni è sicuramente da individuare nel risparmio della spesa.
di Sossio Moccia