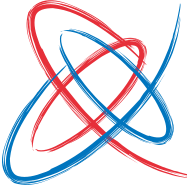Le elezioni israeliane di martedì primo novembre hanno assegnato la vittoria alla coalizione di centro-destra, o per meglio dire alla destra tout court visto che assieme al Likud, il partito conservatore dell’ex – e futuro – premier Benjamin Netanyahu, sono stati determinanti i voti di forze politiche come il partito sionista, lo Shas e il Giudaismo unito della Torah, formazioni (come suggeriscono alcuni nomi) ispirate al conservatorismo e al nazionalismo religioso. Le elezioni hanno registrato, invece, il crollo delle sinistre (appena 4 seggi ai laburisti), a riprova della virata a destra dell’elettorato, mentre le liste arabe hanno pagato lo scotto di essersi presentate divise. Si è trattato dell’ennesimo capitolo di una lunga vicenda politica, che ha visto gli israeliani tornare alle urne per ben cinque volte nell’arco di circa tre anni e mezzo. Smentendo i sondaggi (come abbiamo visto parlando delle presidenziali brasiliane, ultimamente non ne azzeccano una…) la partecipazione al voto è stata significativa: più del 70 per cento degli aventi diritto si è recato alle urne, registrando la più alta affluenza dal 1999, con una importante partecipazione della componente araba (circa il 20 per cento della popolazione d’Israele). Nell’ultimo anno al governo c’era stato il cosiddetto tandem Bennett-Lapid (dai nomi dei leader della maggioranza, questo ultimo come primo ministro), insediatosi a marzo 2021 dopo aver estromesso proprio Netanyahu. Tuttavia, la maggioranza si era rivelata assai debole, sia per i numeri risicati (61 seggi su 120 alla Knesset, il Parlamento dello stato ebraico), che per la eterogeneità delle forze che la componevano, che andavano dalla destra di Yamina, fino alla sinistra araba. In effetti, l’unico trait d’union era costituito dalla comune avversione verso l’ex premier (Bibi per gli amici) ed era bastata ad aprile scorso l’uscita dalla maggioranza di una singola parlamentare, Idit Silman, per mettere in crisi la compagine. La ragione ufficiale della scelta sono stati i contrasti su un disegno di legge contrario alle tradizioni alimentari religiose, ma secondo alcune voci dietro la decisione della Silman ci sarebbe stato lo stesso Netanyahu, che l’avrebbe convinta a questo passo con la promessa di un seggio sicuro e di un posto nel nuovo governo. Una nuova crisi politica, verificatasi ad inizio estate, ha segnato la fine dell’esperienza del governo di larga coalizione. Le nuove elezioni si sono caratterizzate da subito come una sorta di referendum sulla figura di Netanyahu, il quale ha incentrato sulla sua persona la campagna elettorale, avendo sempre conservato il pieno controllo del suo partito. Bibi è il primo ministro più longevo della storia del paese, in carica dal 1996 al 1999 e poi dal 2009 al 2021 (nel 2019 ha superato il record di David Ben Gurion), che è riuscito a conservare al Likud la maggioranza relativa, 32 i seggi guadagnati nelle ultime elezioni, che assieme a quelli dei suoi probabili alleati gli garantiranno un margine di 64 voti. Il problema, come dicevamo, potrebbe derivare proprio dai futuri alleati di governo, tra i quali spiccano forze e personalità con posizioni estremiste. Un esempio viene dalla lista del potere sionista, nelle cui fila è stato eletto Itamar Ben-Gvir, sospettato in gioventù di posizioni razziste e antimusulmane, noto per le prese di posizione contro i palestinesi e a favore dei coloni, palesati con tanto di minacce e giri per i quartieri arabi di Gerusalemme con armi al seguito (alcune voci lo indicano come futuro ministro per la pubblica sicurezza). Anche gli altri partiti di destra, Shas e Giudaismo unito, sono espressione dell’ebraismo ultraortodosso. Non ci vuole molto a capire come queste forze – con un peso elettorale nel loro insieme pari a quello del Likud – faranno valere tutta la loro influenza su temi come sicurezza e difesa dei valori tradizionali – ricordiamo la legge sul carattere esclusivamente ebraico dello stato di Israele, approvata con Netanyahu nel 2018 -, ma soprattutto sulla questione palestinese. Non a caso, il primo ministro dell’ANP (Autorità Nazionale Palestinese) Mohammad Shtayyeh, ha già espresso tutte le sue preoccupazioni, non escluso un acutizzarsi delle tensioni e un aumento delle colonie ebraiche nei territori occupati della West Bank. La tensione è palpabile in Cisgiordania, dove si sono già verificati nuovi scontri tra forze israeliane e milizie palestinesi. Qualche timore è stato espresso anche sulla tenuta degli accordi di Abramo del 2020, coi quali – ricordiamo – erano state allacciate relazioni diplomatiche tra Tel Aviv e Bahrein ed Emirati Arabi Uniti, intese firmate proprio dall’allora premier Netanyahu. Il forte peso politico della destra preoccupa anche gli Occidentali, a cominciare dagli alleati di ferro dello stato ebraico, gli Stati Uniti: per bocca del portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price, gli USA auspicano il rispetto della società democratica e delle minoranze, mal celando una certa riserva sul nuovo corso, a cominciare proprio dall’eventuale inclusione nella compagine governativa di un estremista come Ben-Gvir, mentre già si parla di un altro “falco”, Bazel Smotrich, come nuovo ministro della Difesa. Per queste ragioni, alcuni analisti israeliani non hanno escluso che Netanyahu cerchi l’appoggio del partito centrista di Benny Gantz (12 seggi), ministro uscente della Difesa, quale alleato più moderato rispetto alle destre religiose; ricordiamo che lo stesso Gantz era stato uno dei principali competitor di Bibi nelle elezioni del 2019. Se palestinesi e statunitensi non hanno accolto con particolare favore la maggioranza uscita dalle elezioni, ancor meno entusiasmo – per usare un eufemismo – arriva dai paesi del Medio Oriente. Lasciando da parte le dichiarazioni ufficiali, perplessità arrivano dagli ambienti diplomatici della Turchia (paese che intrattiene regolari relazioni diplomatiche con Tel Aviv) e dalle monarchie del Golfo, mentre l’Arabia Saudita, per voce del principe ereditario Mohammed bin Salman, in occasione di un incontro dell’estate scorsa col presidente americano Joe Biden, dove questi caldeggiava l’avvicinamento con lo stato ebraico (in funzione antiraniana), ha ribadito che non vi sarà la normalizzazione delle relazioni diplomatiche fin quando non si arriverà alla definizione della questione palestinese. Parlando con la CNN, Netanyahu ha escluso qualunque accordo con forze o nazioni che neghino il diritto all’esistenza dello stato ebraico o ostili alla politica degli alleati americani. Non vanno dimenticati i cittadini israeliani di nazionalità araba (circa un quinto della popolazione), che continuano a vivere una condizione fortemente discriminatoria – come per l’accesso di servizi pubblici o per il servizio militare dal quale sono esclusi – oltre che essere affetti da tassi di povertà e disoccupazione più elevati rispetto ai concittadini ebrei, nonostante l’esecutivo uscente avesse visto per la prima volta la partecipazione del partito arabo di Ra’am. Altra questione sul tappeto è la tenuta dell’accordo col Libano del 27 ottobre scorso – uno stato col quale non esistono relazioni diplomatiche e col quale formalmente Israele è in guerra dal 2006 – per la demarcazione dei confini marittimi e dei giacimenti gasieri: l’intesa voluta dal premier uscente Yair Lapid è stata duramente criticata proprio da Benjamin Netanyahu (che ha parlato di concessioni a Hezbollah), che potrebbe pertanto decidere di revocarla; e poi c’è il negoziato sul nucleare iraniano (cui abbiamo dedicato un altro episodio),al quale il nuovo governo di destra potrebbe dichiararsi nettamente contrario. Bibi ha i suoi problemi anche sul fronte interno, per via di una serie di scandali e accuse di corruzione, frode e abuso di potere che pendono sul suo capo e che potrebbero provocare una crisi politica, a meno che il suo ritorno alla guida del governo non ne comporti un annullamento (o un congelamento), come auspicato da ambienti vicini al premier in pectore. E non potranno essere trascurate le istanze degli stessi elettori ebraici, che esprimono preoccupazioni su inflazione e crisi economica. Venendo alle conclusioni, le componenti estremiste che potrebbero essere incluse nel nuovo governo – forse il primo stabile dopo una fase di grande incertezza politica – non rappresentano un passo avanti (casomai parecchi indietro) in direzione di un processo di pace e convivenza pacifica che ancora oggi, per responsabilità interne e internazionali, non è mai stato raggiunto, e del quale – per dirla tutta – ormai non si parla quasi più. Come scriveva Zeev Sternhell, storico israeliano scomparso poco più di due anni fa: “Credere in uno Stato binazionale non significa che le comunità che ne fanno parte rinuncino alla propria identità. Integrazione non è sinonimo di omologazione, di azzeramento delle diversità. Io penso che siano giuste le ambizioni dei palestinesi a voler essere persone libere, le loro aspirazioni al benessere. Soprattutto per i giovani. Credo che nelle condizioni date questa aspirazione sia più praticabile in uno Stato binazionale”. Riprendiamo anche le parole di Lucio Caracciolo, nel suo editoriale su Limes dello scorso anno dedicato proprio alla questione israelo-palestinese: “Quando Israele ci ha provato illudendosi di rimuovere ad infinitum la questione palestinese, considerando separatamente arabi interni e arabi esterni, ha finito per enfatizzare il suo tormento identitario. Questi nodi non si recidono a fil di spada. Si trattano con le armi del negoziato o con il negoziato delle armi. Per il tempo visibile, dosando entrambe le terapie.” Chissà che mettendo da parte gli estremismi, non si faccia tesoro di queste parole. In tutta onestà, alla luce del risultato elettorale e di tutta una serie di dinamiche, c’è poco da essere ottimisti.
di Paolo Arigotti