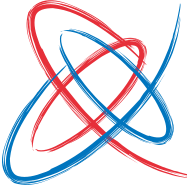Il Libano fu un possedimento dell’Impero ottomano, nell’ambito della Grande Siria, a partire dal XVI secolo e sino alla fine della Grande guerra, caratterizzandosi nei secoli come una sorta di ponte tra cristianità e Islam. Pur passando attraverso varie dominazioni, difatti, non si sono mai interrotti i rapporti politici, economici e commerciali con varie potenze straniere.
Parlando di quelle italiane, importanti relazioni furono coltivate, per esempio, con la Toscana o con le repubbliche marinare di Genova e Venezia, tanto che ancora oggi il nostro è uno dei principali partner commerciali del Libano. Un altro esempio è quello dei francesi, i quali, alleati degli ottomani in funzione antiaustriaca, ottennero dal sultano turco speciali condizioni di autonomia per i territori corrispondenti all’attuale nazione. Lo speciale status, purtroppo, non impedì che nel corso del XIX secolo e verso la fine del primo conflitto mondiale, ci fossero fasi caratterizzate da persecuzioni e violenze contro la locale comunità cristiana. Quando l’impero ottomano si dissolse, al termine della Prima guerra mondiale, i trattati di pace (poi ratificati dalla Società delle Nazioni) attribuirono alla Francia il protettorato (“mandato”) sul Libano (e sulla Siria). Nel 1920, proprio su iniziativa francese, fu decretata la costituzione dello stato del Grande Libano, con capitale Beirut, che contava al suo interno componenti cristiane (allora maggioritarie) e musulmane (sunniti e sciiti), per quanto la nuova entità politica restasse sotto il mandato di Parigi. Nel 1926 venne creata la Repubblica libanese, sempre in orbita francese, che si dotò di una propria costituzione, approvata dal locale consiglio rappresentativo, il quale elesse il primo presidente nella persona di Charles Debbas, un giurista di fede greco ortodossa. La dichiarazione d’indipendenza arrivò nel pieno della Seconda Guerra Mondiale (novembre 1943), mentre la Francia si trovava sotto l’occupazione nazista. Il Regno Unito, che sempre per mandato della Società delle Nazioni controllava altre realtà dell’area mediorientale (come Sudan, Egitto, Palestina, Giordania e Iraq), occupò Siria e Libano, ponendoli formalmente sotto l’autorità della Francia libera di Charles De Gaulle. Il consiglio rappresentativo, ribattezzatosi Assemblea Nazionale, l’8 novembre 1943 dichiarò la fine del protettorato francese, provocando la dura reazione della Francia Libera, che trasse in arresto il presidente libanese Bishara al-Khuri e diversi esponenti del movimento indipendentista. Solo dopo la conclusione del conflitto mondiale (1946) avvenne il ritiro delle truppe anglo francesi – non più in grado di controllare quei territori – evento che pose di fatto termine alla dominazione europea. Gli accordi all’interno del fronte indipendentista (il cosiddetto patto nazionale siglato nel 1943), formalmente ancora in vigore, prevedevano (e prevedono) che nel Libano indipendente le cariche politiche e militari sarebbero state suddivise tra i diversi gruppi religiosi: in pratica, il presidente della Repubblica (eletto dal parlamento e titolare della funzione esecutiva, unitamente al governo da lui stesso nominato) è cristiano maronita, il primo ministro è sunnita e il presidente del parlamento sciita. Lo stesso criterio di ripartizione etnica e religiosa vale per i meccanismi che presiedono all’elezione dei deputati. Nel 1953 il Libano riconosceva il diritto di voto alle donne, le quali, però, ancora oggi hanno una rappresentanza politica poco più che residuale. Nel 1990 è stato inserito in Costituzione il principio di parità tra cristiani e musulmani, portando il numero dei deputati agli attuali 128. Nonostante sia sempre rimasto in vigore un assetto costituzionale e democratico, il paese ha avuto una storia molto tormentata nel corso del secondo dopoguerra. Il Libano conobbe negli anni Cinquanta e Sessanta un importante sviluppo, grazie alle riforme promosse dal presidente Fuad Shihab, che ne fecero un importante centro economico e finanziario. Il paese, inoltre, ha continuato a intrattenere una fitta rete di relazioni con l’Occidente, favorite dalla disciplina del segreto bancario, che ne ha fatto un vero e proprio paradiso fiscale, che gli è valso l’appellativo di “Svizzera del Medioriente”. Nonostante alcune recenti leggi abbiano cercato di contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro, permangono la sostanziale assenza di restrizioni per i movimenti di capitale e gli investimenti provenienti dall’estero (al pari della segretezza sui dati dei correntisti), mentre perfino durante la guerra civile i servizi finanziari e assicurativi non si siano mai interrotti, confermando per il Libano un ruolo di “agenzia finanziaria” e di comodo rifugio per affari e traffici, che – volendo essere ottimisti – sono caratterizzati da scarsa trasparenza. Visto il contesto politico e geografico nel quale si inserisce, non sono mancate fasi di disordine e instabilità, sfociate nella sanguinosa guerra civile di fine secolo. Al pari degli altri membri della Lega Araba, il Libano non riconobbe Israele e, pur senza mai prendere parte alle operazioni belliche, fornì aiuto e supporto logistico in occasione del primo conflitto arabo israeliano (1948). Nel 1949 fu firmato un armistizio con lo stato ebraico, ma solo nel 2007 si arrivò a siglare un vero e proprio trattato di pace, anche se i due stati non hanno mai allacciato relazioni diplomatiche. Il Libano non prese parte alle successive fasi di conflittualità con lo stato ebraico, come la crisi di Suez (1956), la guerra dei sei giorni (1967) o quella del Kippur (1973), ma ne fu indirettamente coinvolto in quanto, già dopo la guerra del 1948, cominciarono ad affluire nel paese oltre 100mila profughi palestinesi, in fuga da Israele, ai quali si aggiunsero quelli della guerra del 1967 e gli altri provenienti dalla Giordania nel 1970. Fu proprio questo importante afflusso di palestinesi di fede islamica (stimato in circa due milioni di persone) che rovesciò i rapporti di forza tra le confessioni religiose in Libano: i cristiani divennero minoranza, gettando le basi per la guerra civile. Il conflitto interno durò dal 1975 al 1990, e venne combattuto tra la fazione cristiana maronita (che faceva riferimento al partito falangista di Pierre Gemayel) e quella musulmana, rappresentata dai palestinesi, a loro volta sostenuti da sunniti e sciiti. Nel 1976 ci fu l’intervento militare della Siria, mentre ad ottobre dello stesso anno la Lega Araba decise l’invio di un contingente militare (sempre a guida siriana), con l’obiettivo ufficiale di riportare la pace. Nel 1978 anche Israele entrò nel conflitto, occupando il sud del Libano, col proposito di allontanare le forze palestinesi dell’OLP dai propri confini. Fu a questo punto che l’ONU decise di inviare una forza di interposizione, che però non riuscì a mettere fine al conflitto. Nel 1982, difatti, partì una nuova offensiva israeliana, che occupò aree ancora più vaste a sud del paese, scatenando quella che viene ricordata come la prima guerra israelo-libanese. L’intervento di un nuovo contingente internazionale, composto da americani, francesi e italiani (Missione Italcon), sempre sotto l’egida dell’ONU, permise la fuga dei vertici dell’OLP, che si trasferì il proprio quartier generale a Tunisi, mentre – allo stesso tempo – gran parte delle forze palestinesi cercò riparo negli stati arabi confinanti. In questa fase del conflitto si verificarono alcune delle stragi più efferate ai danni dei civili: dopo quella di Damur (1976), avvenne il massacro nei campi profughi di Sabra e Shatila (1982), a Beirut. La prima si consumò per mano dei miliziani palestinesi del campo di Tell al-Zatar, mentre la seconda fu responsabilità delle unità cristiane di Elie Hobeika; le forze israeliane, presenti nel teatro di guerra, furono accusate di non aver fatto nulla per impedirne la consumazione. Il 23 ottobre 1983 due attentati esplosivi (opera degli sciiti Hezbollah) colpirono le basi della Forza Multinazionale di pace, uccidendo 241 marines statunitensi e 56 soldati francesi, facendo maturare la decisione di ritirare la missione di pace: in pratica, il Libano veniva abbandonato al suo destino. Il conflitto finì ufficialmente nel 1989, con gli Accordi di pace di Taif. Il nuovo governo, presieduto dal generale Michel Aoun, durò appena un anno e fu deposto dai siriani nel 1990, inaugurando una nuova fase politica, nella quale, de facto, il Libano divenne un protettorato di Damasco. I governi filosiriani vietarono l’azione politica e militare delle fazioni cristiane più radicali, ma allo stesso tempo avviarono la ricostruzione del paese. Nel 2005, dopo l’assassinio dell’ex primo ministro sunnita Rafiq al-Ḥariri, ci fu la cosiddetta “Rivoluzione del Cedro” antisiriana, che consentì di avviare il ritiro delle truppe siriane di occupazione (la cosiddetta Forza Araba di Dissuasione – FAD). Il paese, però, resta ancora oggi al centro di scontri interreligiosi, fomentati dai miliziani sciiti (Hezbollah) sostenuti dall’Iran, responsabili di diversi attacchi e attentati diretti contro il territorio e le forze d’Israele. Lo stato ebraico, a sua volta, ha sempre reagito (e continua a farlo) alle incursioni sciite con aggressioni militari in territorio libanese, ivi compresi attacchi aerei diretti tanto contro obiettivi civili, che militari. Nell’uno e nell’altro caso le operazioni hanno provocato (e continuano a farlo) vittime, violenze e devastazioni, quasi sempre ai danni delle popolazioni inermi, con reciproci scambi di accuse per le varie atrocità. Per mettere fine agli scontri tra lo stato ebraico e i miliziani musulmani (sostenuti da Teheran), il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha votato all’unanimità la risoluzione 1701 del 2006, che ha previsto la creazione di corridoi umanitari per i profughi e l’invio di una nuova forza d’interposizione (UNIFIL), la cui guida nel 2007 fu affidata all’Italia (cd. Operazione Leonte). Nuovi scontri politici, questa volta all’interno del fronte musulmano (tra sunniti e sciiti) si verificarono nel 2008, ai quali si è posto fine solo grazie alla mediazione del Qatar, che promosse una sorta di compromesso politico, con l’elezione del generale Michel Suleiman alla presidenza. Le successive elezioni generali, celebrate nel 2009, videro per la prima volta confrontarsi due blocchi divisi non sulla base dell’appartenenza religiosa, bensì della posizione (o meno) filosiriana: a vincere fu il fronte contrario a Damasco, che riuniva i maroniti con gli alleati drusi e sunniti, che prevalse sugli sciiti alleati del maggiore partito maronita; ad ogni modo, per garantire il consolidamento della pace, si preferì dare vita a un governo di unità nazionale. Nel giugno 2020 il Libano è stato il primo paese del mondo arabo a legalizzare il commercio interno della cannabis – della quale è tra i primi produttori mondiali – per scopo terapeutico e industriale, acutizzando nuovi scontri interni al fronte sciita tra Amal e Hezbollah, legati ai rispettivi interessi attorno al traffico illecito di droga. Lo scoppio della guerra civile in Siria (2011) ha provocato nuove fratture interne: i sunniti si sono schierati coi ribelli, gli sciiti ed Hezbollah col governo di Bashar Al-Assad. Il conflitto siriano ha sconfinato più volte in Libano, con scontri armati, attentati e rapimenti che hanno coinvolto perfino grandi città come Beirut, Sidone e Tripoli. La guerra ha determinato anche il rinvio delle elezioni del 2013, mentre nel 2016 venne rieletto alla presidenza (a 30 anni di distanza dal primo mandato) il generale Aoun, col sunnita Saad Hariri alla guida del governo. Le elezioni del 2018 hanno visto la vittoria del partito del presidente (Alleanza 8 marzo), ma l’escalation del conflitto siriano ha impattato pesantemente sulle finanze del paese, incrementando il deficit e l’indebitamento con l’estero, traducendosi in una devastante crisi economica interna, che ha scatenato una serie di proteste trasversali alle varie fazioni. I movimenti popolari chiedevano, nella sostanza, le dimissioni della classe dirigente, la fine del sistema settario e l’indipendenza del Paese dall’influenza più o meno diretta di Stati terzi (leggi Siria e Iran), assieme e profonde riforme sociali ed economiche, raggiungendo – alla fine del 2019 – un primo risultato, con le dimissioni il premier Saad Hariri, sostituito da Hassan Diab, considerato vicino agli sciiti, a sua volta dimessosi dopo l’esplosione nel porto di Beirut. Va detto che, almeno sino al 2018, il sistema finanziario libanese aveva retto nonostante la crescente instabilità politica e sociale: nel mese di maggio di quell’anno, in occasione di un’intervista al Sole 24 Ore, il potente governatore della Banca centrale di Beirut, Riad Salameh, dichiarava che i depositi totali nel Paese superavano di più di tre volte il Pil nazionale, pure grazie alle rimesse dei connazionali all’estero. Da quel momento in poi, però, le cose cominciarono lentamente a peggiorare. L’enorme afflusso di profughi siriani, al quale il paese era assolutamente impreparato – parliamo di 1,5 milioni di persone, circa 1/3 dei 5 milioni di abitanti di un paese grande più o meno come l’Abruzzo – associato all’aumento vertiginoso di deficit e debito con l’estero provocarono la progressiva contrazione dei depositi, mentre larga parte delle riserve di valuta estera venivano bruciate nel disperato tentativo di ridurre l’indebitamento. Si era innestata la spirale del debito: in pratica, il Libano, in particolare la banca centrale, aveva pagato gli interessi dei vecchi prestiti accendendone sempre di nuovi e offrendo interessi sempre più elevati per attrarre gli investitori (una sorta di schema di Ponzi), finendo per generare il default del marzo 2020, quando il governo dichiarò l’impossibilità di pagare l’Eurobond in scadenza di 1,2 miliardi di dollari. Il fallimento si è riverberato sulle famiglie, che hanno perso circa il 90 per cento del proprio potere d’acquisto, al punto che in molti hanno preferito tornare al baratto, creando a tal fine diversi gruppi sui vari social, come i Lebanon Barters. Allo stesso tempo, molte banche hanno bloccato (o fortemente limitato) i prelevamenti di contante agli sportelli. In un simile contesto si è innestata la pandemia, che ha affossato il vitale settore turistico e fatto emergere ancora di più i tratti clientelari e inefficienti del potere politico. Infine, il 4 agosto 2020 l’esplosione accidentale di 2750 tonnellate di nitrato d’ammonio (un composto chimico utilizzato sia come fertilizzante, che per produrre due tipi di esplosivo), stipate nel porto di Beirut dal 2014, ha distrutto buona parte della capitale, causando centinaia di morti, migliaia di feriti e centinaia di migliaia di senza tetto. A questo aggiungiamo che la mancanza di medicinali e di energia ha provocato il blocco dell’assistenza sanitaria e di molte attività economiche – non si contano i blackout nelle case e nei servizi pubblici – dando ragione alla celebre definizione coniata dal giornalista britannico Robert Fisk, che parlò del Libano come di una “nazione martire”. La stessa esplosione ha provocato la perdita di più del 50 per cento delle riserve di grano (il silo che le conteneva si trovava proprio all’interno dello scalo) e il porto di Beirut, dal quale transitava più di metà dell’interscambio commerciale complessivo, è divenuto inutilizzabile per lungo tempo. Sulla deflagrazione ha indagato il giudice istruttore Tarek Bitar, trasformatosi in una sorta di simbolo della lotta contro il sistema di potere che domina il paese, che ha fatto di tutto per ostacolare l’operato del magistrato, tanto che ancora oggi non sono state chiarite le dinamiche all’origine del disastro. L’evento ha fatto esplodere nuove proteste popolari contro il governo, accusato di omissioni o inefficienza, tra l’altro per non aver rimosso e/o messo in sicurezza il deposito saltato in aria. Negli scontri di piazza ha perso la vita un poliziotto, mentre molti osservatori hanno paventato il rischio dello scoppio di una nuova guerra civile. Nelle intenzioni del governo, per tentare di ridurre il debito pubblico (che ha raggiunto il 170 per cento del PIL a fine 2020) e frenare l’inflazione galoppante, dovrebbe essere varato un importante piano di privatizzazioni, che potrebbe coinvolgere, tra le altre, la compagnia di bandiera Middle East Airlines, numerose aziende operanti nei servizi pubblici e lo stesso porto di Beirut; tali misure dovrebbero essere accompagnate dalla riduzione della spesa pubblica e da un inasprimento fiscale su consumi e idrocarburi. Il problema è che esistono molti dubbi circa l’efficacia di tali misure, visto il quadro di grave instabilità politica e sociale, nel quale si accresce sempre di più la forbice tra ricchi e poveri, senza contare il PIL in picchiata, che solo nel triennio 2017/2020 ha registrato un crollo del 30 per cento. Nel mese di aprile 2020 – prima ancora dell’incidente del porto di Beirut – il governo aveva concordato con l’FMI un prestito di 10 miliardi di euro in cambio di un piano di riforme economiche che, passando per la riforma del settore bancario, prevedeva il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego e un inasprimento fiscale; al contrario, il governo ha desistito dal progetto di deprezzare la lira libanese rispetto alla valuta degli USA (passando dagli attuali 1.500 circa a 3.500 per un dollaro), ma già nell’estate del 2020 si registrò un consistente apprezzamento del dollaro nel mercato nero, che toccò un rapporto di 9.000 a 1. Si è parlato anche di aiuti provenienti dalla Russia, che avrebbe interesse a rafforzare la propria influenza nell’area, visto il sostegno ad Assad in Siria. Il varo del piano di aiuti internazionali è stato ostacolato dall’avversione del partito sciita (maggioritario) nei confronti del mondo occidentale (leggi Stati Uniti), ma anche dalla diffusa corruzione e dal profondo settarismo e clientelismo proprio di un assetto sociale ancora radicato su fazioni, ciascuna della quale tende a tutelare solo gli interessi dei proprio affiliati; un esempio pratico è stato offerto in tal senso dalla distribuzione dei vaccini anti-Covid. In sostanza, parliamo di un paese la cui classe dirigente è più attenta alle esigenze del proprio partito o comunità di appartenenza, che della nazione nel suo complesso. A gennaio 2022 la banca mondiale, in un report dedicato, ha definito quella libanese la peggiore crisi finanziaria dal 1850, indicando nella classe politica la maggiore responsabile, con un’inflazione che è arrivata al 145 per cento e circa i ¾ della popolazione che vive – praticamente senza servizi e regolare accesso ai generi di prima necessità – al di sotto della soglia di povertà; a poco è servito l’annuncio del ritiro dalla politica dell’ex premier Hariri, mentre le ultime elezioni – tenutesi il 15 maggio 2022 – hanno visto l’arretramento degli sciiti (che restano comunque la forza di maggioranza relativa) e del partito del presidente Aoun (il cui mandato scadrà il prossimo ottobre), segnando l’avanzata di diversi indipendenti; è molto probabile che, almeno per il momento, rimarrà in carica l’attuale premier Najib Miqati, insediatosi a settembre 2021, considerato l’uomo più ricco del paese e moderatamente vicino alla Siria. Il risultato elettorale, in sostanza, non ha restituito una maggioranza politica certa e questo potrebbe preludere ad una sorta di paralisi politica ed istituzionale, senza contare che la persistente forza degli sciiti, sgradita per evidenti ragioni agli americani per via della loro vicinanza all’Iran (basti ricordare i noti dissapori tra Washington e Teheran sulla questione nucleare), rischia di alimentare una certa ritrosia agli investimenti, dei quali il paese avrebbe disperatamente bisogno. Questi sarebbe visti bene dalla Francia, ma non incontrano il favore degli americani (per le ragioni già esaminate) e men che mai di Israele, che ha tutto l’interesse a depotenziare gli sciiti Hezbollah; da parte loro iraniani e sauditi, rivali storici per l’egemonia nel Medioriente, non hanno saputo finora offrire soluzioni efficaci, per quanto ultimamente l’influenza di Ryad, dopo una fase di declino, pare in risalita. La situazione attuale spinge molti libanesi, a cominciare dai giovani più preparati che possono permetterselo, ad abbandonare un paese senza prospettive, mentre tanti di loro hanno disertato le urne, disincentivati da un sistema politico ancorato a logiche tribali o di appartenenza religiosa, che finiscono per perpetuare gli assetti di potere. Il conflitto ucraino ha avuto i suoi riflessi sul Libano: un paese che già di suo importava la gran parte dei generi di prima necessità, acquistava l’80 per cento del grano dall’Ucraina, quasi tutto il restante dalla Russia, mentre Algeria e Turchia – dalle quali il Libano importava zucchero, cereali e farina – hanno ridotto l’export, per accumulare scorte per il proprio fabbisogno interno. I ben noti aumenti energetici e nei prezzi dei cereali, che stanno già duramente colpendo molte nazioni in crisi (come per esempio lo Sri Lanka), picchiano duro in Libano, dove già si diffondono la fame e il mercato nero, proprio a causa della tendenza storica di fungere quasi esclusivamente da centrale finanziaria, importando dall’estero piuttosto che produrre in casa quel che gli serve, a cominciare dai generi di prima necessità. Non migliore la situazione energetico-ambientale, che presenta forti criticità dovute alla cementificazione selvaggia e connessa deforestazione, al fenomeno delle discariche e delle cave abusive, alla contaminazione delle fonti idriche e all’inquinamento di diversa natura (per esempio, con l’accumulo di enormi quantità di rifiuti solidi urbani), fenomeni acutizzati dall’importante afflusso di profughi siriani. Si è parlato, è vero, di incentivare il ricorso a fonti alternative, a cominciare dall’energia solare (un paese con 300 giorni di sole all’anno!), ma di fatto mancano mezzi e risorse per farlo. La banca mondiale, ai primi di maggio di quest’anno, – secondo quanto riferito all’agenzia Reuters dal ministro libanese dell’Economia Amin Salam – ha approvato un prestito ponte (cd. Lebanon Wheat Supply Emergency Response Project) pari a 150 milioni di dollari, per supportare il paese negli approvvigionamenti di grano e calmierare i prezzi, mentre si profilano all’orizzonte nuovi investimenti nel settore dell’agritech da parte degli Emirati Arabi Uniti. In conclusione, preso atto del quadro davvero sconfortante che vive l’ex Svizzera mediorientale, il Libano può solo sperare nei finanziamenti e negli aiuti esteri per non precipitare ancora di più nell’abisso. Ma se pure questi arrivassero, non si dovrebbe trascurare di aggredire e risolvere le vere cause della situazione, pena il suo reiterarsi: il sistema politico e di potere inefficiente e corrotto, le divisioni etnico religiose ostacolo allo sviluppo, l’assenza di una visione di lungo periodo, che ha privilegiato logiche speculative agli investimenti per la crescita. Ben più difficile, invece, incidere su fattori esterni come il conflitto siriano o gli assetti geopolitici del Medioriente, a patto, però, che non diventino un alibi per non risolvere le importanti criticità interne.
di Paolo Arigotti