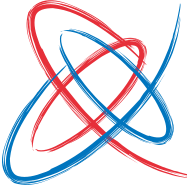Il 10 giugno 1924 è un caldo pomeriggio estivo a Roma. Il deputato e segretario politico del Partito Socialista Unitario, On. Giacomo Matteotti, lascia la sua casa in Via Pisanelli 40, nei pressi del lungotevere Arnaldo da Brescia.
Come sempre (familiari ed amici lo descrivevano come un abitudinario) avrebbe percorso il viale, in direzione di piazza del Popolo, dove sarebbe salito sul tram 15 per recarsi a Montecitorio. Aveva già trascorso la mattinata alla Camera, e dopo essere rientrato a casa per il pranzo, aveva intenzione di tornarci per andare in biblioteca, per ultimare la raccolta di atti e documenti in vista del discorso che avrebbe dovuto pronunciare in aula il giorno seguente. Non sarebbe stato quello il suo primo intervento di fuoco nelle aule parlamentari, dove sedeva da tre legislature (era stato eletto la prima volta nel 1919, per poi essere confermato nelle due successive tornate elettorali del 1921 e 1924): in particolare, aveva destato grande scalpore il suo discorso del 30 maggio, quando prendendo la parola circa le elezioni generali del 6 aprile, aveva mosso una serie di circostanziate e pesanti contestazioni sulla validità delle votazioni, denunciando un clima di violenze, intimidazioni e brogli che ne avrebbero falsato l’esito, arrivando a chiederne l’annullamento. Il suo intervento era stato disturbato, spesso interrotto, dalle grida dei deputati di maggioranza, specialmente i fascisti, che non gli risparmiarono insulti e minacce, neanche troppo velate. Seduto sui banchi del Governo, ad ascoltare la filippica, un Benito Mussolini pallido e furente, che restò in silenzio per tutto il tempo, manifestando a tratti insofferenza verso la baraonda fatta dai suoi. Inutili i tentativi di riportare l’ordine da parte del presidente di turno, Enrico De Nicola, che ad un certo punto raccomandò a Matteotti di concludere, senza provocare incidenti. La reazione del deputato socialista fu quanto meno stizzita: replicò al Presidente che il suo intervento era del tutto in linea con l’ordine del giorno (dedicato, appunto, alla convalida dei risultati elettorali) e che la presidenza doveva garantire il suo diritto di parlare. Cadde nel vuoto anche l’esortazione alla prudenza di De Nicola: Matteotti precisò di non volere parlare prudentemente o imprudentemente, ma parlamentarmente. L’intervento, tra mille difficoltà, si concluse dopo oltre un’ora e fu lo stesso Matteotti che, rivolendosi ai suoi colleghi di partito, fece un’affermazione che si rivelerà – purtroppo – profetica: “Io il mio discorso l’ho fatto, ora a voi preparare il discorso funebre per me.” Chi era Giacomo Matteotti? Nato a Fratta Polesine, provincia di Rovigo, il 22 maggio 1885, apparteneva ad una famiglia ricca e benestante. Il padre Girolamo aveva investito i proventi del commercio di ferro e rame in case e terreni, conquistando un’autentica fortuna: più tardi la stampa cattolica indicherà nello strozzinaggio, accusa peraltro mai provata, la vera natura delle fortune della famiglia Matteotti. Giacomo si laureò in giurisprudenza a Bologna nel 1907, ed è lì che entrò in contatto coi circoli socialisti, seguendo l’esempio paterno che era stato (prima di scomparire prematuramente nel 1902) consigliere comunale nelle fila dello stesso partito, a Fratta Polesine. La sua estrazione privilegiata gli avrebbe senz’altro consentito di abbracciare, senza problemi, la carriera accademica o quella politica nelle fila dei conservatori: scelse, invece, di dedicare la sua vita alla causa del bracciantato agricolo. A causa della condizione di unico figlio superstite di madre vedova, fu dispensato dall’arruolamento per la Grande guerra, senza mai nascondere le sue posizioni nettamente neutraliste, che gli sarebbero costate tre anni di confino in Sicilia (dopo il formale richiamo alle armi), nei pressi di Messina. Nel 1916 sposò, con rito civile, la poetessa romana Velia Titta (sorella del baritono Ruffo); dall’unione nasceranno tre figli: Matteo, Isabella e Giancarlo. Dopo l’esperienza di amministratore locale e quelle professionali, sempre al fianco delle istanze dei lavoratori della sua provincia (all’epoca una delle più povere del settentrione) venne eletto deputato nel 1919 e nel 1921, mentre nell’ottobre del 1922 fu espulso dal partito socialista – in quanto militante della corrente riformista, capeggiata da Filippo Turati – e fu tra i fondatori del partito socialista unitario, divenendone segretario politico. La sua opposizione verso il Fascismo è manifesta fin da subito, anche attraverso l’impegno di segretario della camera del lavoro di Ferrara dal 1920; nel 1921 darà alle stampe la sua Inchiesta sulle gesta dei fascisti in Italia, con la quale denunziava pubblicamente il clima di violenze creato dallo squadrismo. Soprannominato, non certo a caso, Tempesta dai suoi compagni per il suo piglio battagliero, dedicava molto tempo all’attività di studio e documentazione, pubblicando nel 1924 un nuovo scritto Un anno di dominazione fascista, che dovette uscire a Londra (dove egli fece l’ultimo dei numerosi viaggi all’estero, dopo essersi più volte visto negato il passaporto) col titolo The Fascists exposed; a year of Fascist Domination, recante una nuova e circostanziata descrizione delle violenze fasciste, contestandone la loro prosecuzione dopo un anno dalla presa del potere, in evidente contraddizione con le dichiarazioni ufficiali di Mussolini per un ritorno all’ordine e alla legalità. Non meno assidua l’attività parlamentare: si conteranno ben 106 interventi in aula, accompagnati da numerosi disegni di legge e relazioni (coi suoi discorsi parlamentari sarebbe possibile riempire ben 1398 pagine!). Le posizioni di Matteotti sono palesemente antitetiche al Fascismo, non ancora divenuto regime. Per la verità, in gioventù aveva incrociato Mussolini, allora socialista, in occasione del congresso del partito del 1912; il futuro Duce fu tra i promotori della decisione di espellere gli esponenti dell’ala destra Bissolati e Bonomi, favorevoli alla guerra di Libia. Matteotti, nonostante fosse un convinto antimilitarista, pare non fosse favorevole alla loro estromissione dal partito. Indubbiamente le sue posizioni e quelle di Mussolini si fecero via via sempre più distanti, specie dopo la svolta interventista di quest’ultimo e la sua espulsione dal partito, per poi divenire diametralmente opposte dopo la fondazione dei Fasci di combattimento nel 1919 e lo scatenamento delle violenze politiche.
La nomina di Mussolini alla guida del governo il 30 ottobre 1922 e i primi provvedimenti varati dal nuovo esecutivo, in questa prima fase sostenuto – giova ricordarlo – da un ampio arco costituzionale, composto tra gli altri da liberali e popolari (il partito fascista era ancora in minoranza alla Camera), vide Matteotti sempre schierato all’opposizione più intransigente, manifestata pure in occasione dell’approvazione della legge elettorale maggioritaria, cosiddetta Legge Acerbo, che avrebbe costituito lo strumento legale per la definitiva conquista del potere. Sarebbe stato proprio contro i risultati delle elezioni del 6 aprile, regolate dal nuovo sistema elettorale, che si sarebbe scagliato Matteotti, contestandone non tanto gli esiti – che probabilmente furono molto più favorevoli al Fascismo di quanto probabilmente lo stesso Mussolini avesse previsto – quanto il clima di violenza e intimidazione che le aveva caratterizzate.
Torniamo a quel fatidico 10 giugno. Sono trascorsi dieci giorni dal discorso che tanta enfasi ha avuto anche sui giornali (ancora liberi) e Matteotti, come accennato, si era già iscritto a parlare per il giorno successivo. Stavolta avrebbe affrontato una questione legata a presunti finanziamenti ricevuti dal Fascismo per favorire le richieste di nuove trivellazioni da parte della compagnia statunitense Sinclair, affiliata alla ben più potente Standard Oil. A quanto pare, tra i maggiori beneficiari delle “mazzette” figurava niente di meno che Arnaldo Mussolini, fratello del capo del Governo e suo successore alla direzione de Il Popolo d’Italia[1]. Un’accusa, neanche troppo velata, di un giro di affari e finanziamenti che avrebbe coinvolto i vertici del Fascismo. Non erano certo un mistero per nessuno i contenuti di questo nuovo discorso: per iscriversi a parlare era necessario anticiparli con una richiesta alla presidenza della Camera, allora ricoperta dal nazionalista (ed alleato di Mussolini) Alfredo Rocco: per questa ragione, possiamo affermare con assoluta certezza che Mussolini ne fosse perfettamente al corrente. Una lancia Lambda a sei posti stazionava da giorni nei pressi dell’abitazione di Matteotti: lo sappiamo grazie alla testimonianza – raccolta nei giorni successivi alla scomparsa dalla polizia – di due portieri, che avevano notato la vettura di lusso e si erano segnati il numero della targa. Non dimentichiamoci che siamo nel 1924: il traffico dell’epoca era ben diverso da quello di oggi, e macchine di quel tipo – una limousine scura particolarmente chic – venivano notate facilmente. A bordo c’erano cinque uomini: Amerigo Dumini, Albino Volpi, Giuseppe Viola, Amleto Poveromo e Augusto Malacria. Si trattava di un gruppo di arditi, tutti di origine lombarda, all’infuori del toscano Dumini. Erano i componenti della cosiddetta Ceka fascista, una polizia politica non ufficiale, incaricata di “sistemare” gli oppositori più scomodi. Due di loro, pare Dumini e Volpi, quando lo videro in cammino, scesero e afferrarono bruscamente Matteotti. Resosi conto dell’aggressione, il deputato reagì con vigore, dibattendosi e contorcendosi, riuscendo a gettare a terra uno degli assalitori. Matteotti, purtroppo, conosceva già le violenze degli squadristi sulla sua stessa pelle: nel 1921 aveva subito una dura aggressione, circolarono perfino voci su presunti abusi sessuali. Di fronte a quella reazione inattesa, intervenne allora un terzo uomo, che gli sferrò un duro colpo in pieno volto, facendogli quasi perdere conoscenza. A quel punto Matteotti venne caricato a forza in macchina, pur trovando la forza per reagire nuovamente e gridare aiuto: gli aggressori non gli risparmiarono nuovi colpi al torace e al basso ventre. A quanto sembra, alla scena assistettero alcuni ragazzi che facevano il bagno nel Tevere (allora era possibile) e che avevano incrociato Matteotti poco prima. La macchina sfrecciò via. Matteotti, però, continuava a dibattersi e urlare, riuscendo a sfondare uno dei vetri e gettare per strada il suo tesserino ferroviario da parlamentare. L’autista Malacria si diresse verso la via Flaminia, passando per ponte Milvio (allora transitabile per le automobili), suonando ripetutamente il clacson per coprire le grida di Matteotti e i rumori della lotta all’interno dell’abitacolo. Fu in quel momento che il deputato sferrò un calcio nelle parti intime di Viola, che d’istinto inferse una pugnalata al torace di Matteotti, provocandone la perforazione del polmone e una morte quasi istantanea. I rigurgiti di sangue fuoriuscirono dalla bocca, imbrattando tutto l’abitacolo e i sedili: nonostante gli inutili tentativi di cancellarli, le tracce rimarranno e saranno rivenute dagli inquirenti dopo il ritrovamento del veicolo. Matteotti era morto e la macchina si diresse in aperta campagna, fino ad arrivare, quando già era buio, nei pressi di Riano Flaminio, nella macchia di Quartarella, a più di venti chilometri da Roma. Con gli utensili della macchina, gli uomini del commando scavarono una fossa dove il terreno era più molle, facendosi luce con dei cerini, e seppellirono il cadavere in fretta e furia, per poi fare ritorno in città. Parcheggiata la vettura in una rimessa privata, informarono dei fatti Filippo Filippelli, direttore del giornale filofascista Corriere Italiano, a nome del quale era stata noleggiata la Lancia ed Emilio De Bono, capo della polizia. Il giorno seguente la moglie e i compagni di partito denunciarono la scomparsa di Matteotti. Intervenendo alla Camera il successivo 13 giugno, Mussolini (all’epoca ministro dell’Interno ad interim) rassicurò i deputati circa le indagini in corso, volte ad accertare le cause della scomparsa, facendo quasi di sfuggita un cenno a controlli alle frontiere, per far passare il messaggio di un possibile espatrio di Matteotti. Sulla natura e dinamiche del delitto torneremo tra poco, quel che possiamo dire con assoluta certezza è che Mussolini stava mentendo. Egli sapeva già della morte di Matteotti: Emilio De Bono, forse Giovanni Marinelli (segretario amministrativo del Partito Fascista e promotore della Ceka) o Aldo Finzi (sottosegretario all’Interno, che a sua volta lo aveva saputo da Filippelli, che lui stesso aveva messo alla direzione del Corriere Italiano) lo avevano prontamente informato. La menzogna non sarebbe finita qui: Mussolini avrebbe, è vero e come vedremo, fatto mettere in prigione i diretti responsabili, mentre il giornale di Filippelli avrebbe cessato le pubblicazioni, ma non ammetterà mai di essere venuto a conoscenza delle dinamiche del delitto praticamente in tempo reale e di aver cercato in tutti i modi, perfino dopo il ritrovamento (probabilmente pilotato) del cadavere il 16 agosto seguente, di celare i fatti. Si trovò praticamente costretto a far mettere in galera i diretti responsabili quando, grazie alla testimonianza dei due portieri, si risalì alla macchina usata per il rapimento, intestata come abbiamo visto a un uomo come Filippelli, a sua volta legato a Cesare Rossi, capo ufficio stampa di Mussolini. La campagna di stampa e l’impressione nell’opinione pubblica – visti i chiari legami tra le persone coinvolte e il capo del Governo – furono molto forti nei primi giorni ed ebbero un ulteriore sussulto dopo il rinvenimento delle spoglie di Matteotti, ma non si andò molto oltre questo. Mussolini assunse un atteggiamento attendista, forse guardingo, confidando nel fatto – lo scrisse molto acutamente Indro Montanelli – che in Italia gli scandali e l’indignazione hanno vita breve. Una mossa strategica fu lo spostamento delle esequie a Fratta Polesine, per impedire che i funerali potessero trasformarsi in una nuova tribuna per le forze dell’antifascismo: ci furono, è vero, omaggi di sostenitori e gente comune, però mancarono celebrazioni o rituali ufficiali. Si è molto discusso circa il nesso causale tra l’uccisione di Matteotti e l’instaurazione della dittatura, usualmente fatta coincidere con il discorso di Mussolini alla Camera del 3 gennaio 1925, quando quest’ultimo assunse la responsabilità morale, politica e storica (ma non giuridica) di quanto accaduto, preannunciando una generale chiarificazione e una serie di nuovi provvedimenti, che avrebbero di fatto gettato le basi per il nuovo regime a partito unico (formalizzato definitivamente con le leggi fascistissime del 1926, che avrebbero messo a tacere le ultime voci libere). Un primo, ma significativo, passo in tale direzione, approfittando del clima seguito al delitto, fu compiuto già il 12 luglio 1924, quando furono approvati (o meglio resi esecutivi) i provvedimenti restrittivi sulla libertà di stampa, che anticiparono le leggi dell’anno seguente che avrebbero definitivamente messo a tacere le voci di dissenso nella carta stampata (contro tali provvedimenti, per la prima volta, si registrò il voto contrario di Giovanni Giolitti). Come anticipato, Mussolini fece arrestare i diretti responsabili, costringendo alle dimissioni Cesare Rossi, capo ufficio stampa della presidenza del Consiglio ed Emilio De Bono (il quale, però, conservò per il momento il comando della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, che di lì a poco sarebbe stata inquadrata nelle forze regolari e sottoposta al giuramento di fedeltà al Re). Finirono in prigione Dumini e tutti i membri del commando, mentre Rossi si costituì il 22 giugno. Cosa c’entrava quest’ultimo? Non prese parte all’aggressione, ma probabilmente ne fu uno degli ispiratori e, basandoci sul suo stesso memoriale scritto poco prima di presentarsi alle autorità (e poi pubblicato sul quotidiano Il Mondo, diretto da Giovanni Amendola), fu lui ad accusare Mussolini di essere il mandante dell’omicidio, dando conto delle frasi pronunciate dal Duce al termine del discorso del 30 maggio, parole infuocate del tipo: “Cosa fa la Ceka?” e “Quest’uomo non deve più circolare!”. Un altro memoriale, scritto stavolta da Filippelli, addossò sempre su Mussolini la decisione della morte di Matteotti. A questo punto, giova soffermarsi sulle tesi avanzate circa le dinamiche del delitto. Riguardo il movente non è necessario, invece, spendere molte parole, visto che sia che si sposi la tesi della “vendetta” per il discorso del 30 maggio, che il timore per le rivelazioni di Matteotti del 11 giugno, è di tutta evidenza che ci si trovava in presenza di un personaggio scomodo e inviso al nascente regime. La domanda, però, deve essere un’altra. Matteotti, per quanto agguerrito e molto preparato, non era certo l’unica voce contraria al fascismo e le denunce per le irregolarità nelle ultime elezioni o per i presunti rapporti affaristici tra la famiglia Mussolini e le compagnie americane non erano un mistero per nessuno. Per questo dovremmo forse chiederci se la morte di Matteotti era veramente il fine ultimo dell’agguato del 10 giugno, indubbiamente pianificato e preparato in precedenza (lo dimostra la testimonianza dei due portieri che avevano notato la vettura in sosta da diversi giorni prima), o fu piuttosto una tragica fatalità, che poi si cercò (inutilmente) di celare all’opinione pubblica. Mussolini fu il vero mandante oppure, per usare una sua espressione, si trovò a dover gestire un cadavere “gettato ai suoi piedi”? Cominciamo col dire che le violenze contro le opposizioni, come correttamente denunziato da Matteotti in tante occasioni, non erano infrequenti, né prima né dopo l’aggressione al deputato socialista. Solo per fare alcuni esempi, ricordiamo il sacerdote Don Luigi Minzoni, assassinato dagli squadristi il 23 agosto 1923, oppure le aggressioni contro Piero Gobetti e Giovanni Amendola, che ne provocarono la morte a posteriori a causa dei traumi subiti; per fare un salto in avanti, ricordiamo ancora l’uccisione dei fratelli Carlo ed Enrico Rosselli in Francia, nel 1937. Questo per significare che nessuno nega il volto violento e criminale dei sicari del regime. Esistono, però, una serie di elementi di cui tener conto, che potrebbero spingere verso altre conclusioni per il delitto Matteotti. Può essere utile, in tal senso, prendere in considerazione tre diversi scenari, tutti sostenuti dalle diverse scuole di pensiero. Tornano, in tal senso estremamente utili i due memoriali citati (Rossi e Filippelli), scritti da uomini che volevano scongiurare il pericolo di diventare dei capri espiatori, o magari per precostituirsi un’assicurazione sulla vita nell’ipotesi, non certo infondata, che qualcuno pensasse di toglierli di mezzo per eliminare degli scomodi testimoni.
Il primo scenario[2] vedrebbe Mussolini in veste di mandante dell’omicidio, per eliminare uno scomodo avversario, o peggio l’artefice di una denuncia delle commistioni tra fascismo e mondo degli affari. Chi sostiene questa ricostruzione può certamente far leva sulle violenze e sulla cura con la quale i membri del commando raccolsero le carte che Matteotti portava con sé, cadute durante l’aggressione, prima di lasciare il lungotevere. Questa costruzione, verso la quale sembrano spingere i memoriali Filippelli e Rossi, non è del tutto convincente. Probabilmente Mussolini voleva che fosse data una lezione a Matteotti, ma da politico acuto aveva compreso che un omicidio così plateale, a breve distanza dal discorso del 30 maggio, gli avrebbe procurato più noie, che vantaggi. Una punizione ci voleva, però magari più avanti, lasciando sbollire l’onda l’emotiva del momento.
Una seconda opzione potrebbe imputare la morte di Matteotti alla volontà di stretti e zelanti collaboratori del Duce (Rossi, Marinelli, Dumini), che interpretando la sua sfuriata dopo il discorso del 30 maggio come una sorte di ordine o desiderio inespresso, avrebbero deciso di “fare un favore” a Mussolini, levando di mezzo un oppositore scomodo. In realtà, la stessa dinamica dell’agguato non fa propendere per l’omicidio premeditato, come emerge dagli atti dell’inchiesta che fu condotta da magistrati indipendenti, come Mario Del Giudice. Tutto farebbe, invece, pensare ad una morte causata da uno scatto d’ira del momento di uno degli aggressori, che reagì al calcio di Matteotti. Le stesse modalità di occultamento del cadavere e delle prove, sbrigative e evidentemente non preparate (abbiamo visto che furono utilizzati gli utensili della macchina), come i dilettanteschi tentativi di eliminare le macchie di sangue dal veicolo porterebbero a pensarlo: del resto, pianificare una cattura in pieno centro, senza pensare di essere visti o riconosciuti?
Questo conduce ad una terza ipotesi[3], a mio avviso la più verosimile. L’obiettivo era quello di dare una “lezione” a Matteotti, non si sa se col placet di Mussolini o meno, trasformatasi in tragedia per il dilettantismo degli aggressori e l’inattesa reazione del parlamentare. Mussolini, come visto, ne venne messo a conoscenza nell’immediato e preso alla sprovvista – non essendo preparato a quella morte scomoda – cercò prima di temporeggiare, poi di dare in pasto all’opinione pubblica dei colpevoli, ma non tutti (abbiamo visto i casi di Rossi e Filippelli) erano disposti ad accettare lo scaricabarile e scrissero dei memoriali per cautelarsi. In tal senso, la stessa cinica espressione del cadavere tra i piedi potrebbe essere, forse, l’unico momento di reale sincerità del Duce in tutta la vicenda, caratterizzata poi da atteggiamenti dilatori e reticenti, forse in attesa degli eventi, nell’idea che poi tutto sarebbe rientrato (ed i fatti gli diedero ragione).
In effetti, è indubbio che col delitto Matteotti il fascismo visse l’ultimo serio pericolo di essere travolto e Mussolini dovette temere non poco una simile eventualità, ma fu certamente favorito da una serie di fattori che giocarono a suo vantaggio. L’opinione pubblica da sola non basta, se non trova sponde in campo politico, e la risposta dell’opposizione, già ridotta numericamente dai meccanismi della legge Acerbo, con la secessione dell’Aventino (in pratica un’astensione dai lavori della Camera), si dimostrò del tutto inefficace e, peggio ancora, privò i partiti di opposizione della tribuna parlamentare per far sentire la loro voce: oltretutto nacquero da subito le prime divisioni (per esempio sulla proposta comunista dello sciopero generale, rigettata dalle altre forze politiche) che certo non aiutarono. Mussolini concordò, dopo la seduta del 13 giugno, con Rocco un aggiornamento sine die dei lavori della Camera, che di fatto misero a tacere le opposizioni e fecero cadere nel vuoto l’iniziativa dell’Aventino. A novembre, alla ripresa dei lavori, i comunisti si sarebbero ripresentati in aula, mentre le altre forze politiche si sarebbero arroccate nella scelta dell’astensione. Un secondo, ma decisivo, fattore fu l’atteggiamento della maggioranza che sosteneva Mussolini e del Sovrano. La prima, composta non soltanto da fascisti, scelse di confermare la fiducia all’Esecutivo, rifiutando qualunque proposta di collaborazione con le opposizioni: alcune defezioni ci furono, ma ebbero carattere personale (tra le più autorevoli quella di Giolitti, peraltro tardiva e maturata solo a novembre 1924). Mussolini pensò bene di blindare la sua maggioranza, presentando a fine dicembre un disegno di legge di riforma elettorale che prevedeva il ritorno al sistema uninominale, paventando uno scioglimento della Camera e il ritorno a nuove elezioni, che con ogni probabilità sarebbero costate il seggio a molti deputati. Il Re, pur sollecitato più volte, non tolse mai l’appoggio al Governo, trincerandosi dietro le sue prerogative statutarie, ma con ogni probabilità temendo che la caduta di Mussolini potesse preludere all’ascesa di forze politiche a lui invise, a cominciare dai socialisti di fede repubblicana. Lo stesso Senato (allora non elettivo e di nomina regia), dove sedevano i rappresentanti di nobiltà, forze armate e alta finanza, così come il mondo degli industriali, scelsero di non abbandonare Mussolini, che diede loro garanzie di tutela delle rispettive sfere di interesse. Un’ultima notazione riguardo il discorso del 3 gennaio 1925: per quanto uno dei più celebri del repertorio mussoliniano, come si può evincere anche dai toni, fu con ogni probabilità frutto di improvvisazione e spinto dal timore di una sollevazione del fascismo più intransigente (famoso il pronunciamento in tal senso dei consoli della milizia in un incontro col Duce, tenutosi il 31 dicembre, col pretesto degli auguri per l’anno nuovo). Quel che è certo è che un discorso di quel tipo era a tutti gli effetti – e nonostante la sottovalutazione delle forze di opposizione – il chiaro preannuncio della dittatura. Un cenno, infine, alle vicende di coloro che furono implicati nel delitto Matteotti. Abbiamo già visto che tutti gli aggressori furono arrestati a pochi giorni dalla scomparsa del deputato socialista. A livello politico Mussolini cedette il ministero dell’Interno al nazionalista Luigi Federzoni e nominò, al posto di De Bono, un prefetto di carriera al vertice della polizia. Il processo farsa fu celebrato a Chieti (Roma fu ritenuta una sede non idonea per legittima suspicione) dal 16 al 24 marzo 1926. A difendere gli imputati, l’avvocato Roberto Farinacci, segretario del PNF ed esponente dell’ala oltranzista del partito. La condanna fu per omicidio preterintenzionale per Dumini, Volpi e Poveromo, gli altri due (Malacria e Viola) furono assolti per insufficienza di prove. Per Emilio De Bono, in qualità di membro del Senato, ci fu un processo a parte dinanzi al parlamento, riunito in Alta Corte di Giustizia, che decretò a novembre il non luogo a procedere. Dumini e gli altri praticamente non scontarono la condanna a cinque anni di carcere e quest’ultimo beneficiò di un trattamento di favore, accumulando una piccola fortuna nelle colonie africane. Nel 1947, caduto il regime, si celebrò un nuovo processo – nel rispetto di un decreto luogotenenziale che dichiarò nulle le sentenze degli organi di giustizia emesse durante il regime, ove superiori ai tre anni – che costarono la condanna all’ergastolo (poi commutata in trenta anni di carcere) per Dumini, Viola e Poveromo, Rossi – che durante il fascismo fuggì all’estero e poi conobbe il carcere ed il confino – fu assolto per insufficienza di prove, gli altri imputati beneficiarono dell’amnistia Togliatti. Dumini tornò in libertà sei anni dopo, e morì a casa sua nel 1967. Marinelli e De Bono furono fucilati a Verona l’11 gennaio 1944, per aver votato contro il Duce nella fatidica seduta del Gran consiglio del 25 luglio 1943. Filippelli conobbe alterne fortune: rientrato in Italia nel dopoguerra dopo un periodo di esilio, si ritirò a vita privata e morì nel 1961.
La vedova Matteotti, signora Velia, che aveva ricevuto le rassicurazioni (ipocrite) di Mussolini all’indomani della scomparsa del marito, si ritirò a vita privata a Fratta Polesine, dopo aver rinunciato a costituirsi parte civile nel processo contro gli imputati. Ebbe frequentemente a lamentarsi della stretta vigilanza nei confronti della sua famiglia, e morì a soli 48 anni, nel 1938, per i postumi di un intervento chirurgico. I due figli, Giancarlo (morto nel 2006) e Matteo (morto nel 2000) si sono impegnati in politica nelle fila dei socialisti
di Paolo Arigotti
[1] La tesi è sostenuta da Mauro Canali, Il delitto Matteotti, Il Mulino.
[2] La tesi è sostenuta da Giovanni Borgognone, Come nasce una dittatura. L’Italia del delitto Matteotti, Laterza, 2018.
[3] Sostenuta, tra gli altri, da Renzo De Felice e Giovanni Sabbatucci.