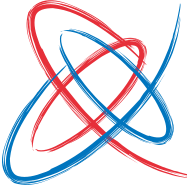Agli inizi di settembre ha preso avvio un nuovo episodio del conflitto tra armeni e azeri, sulla questione del Nagorno Karabah, ma non solo. Il Caucaso si conferma, in questo senso, una regione molto tormentata, mentre una nuova scia di sangue e violenza sembra profilarsi all’orizzonte. Il 23 settembre, parlando all’ONU, il premier armeno ha parlato di torture orribili e mutilazioni compiute dagli azeri. Non ci soffermeremo sulle origini di una guerra, che, a corrente alternata, si protrae da circa trent’anni: cercheremo piuttosto di capire le ragioni che hanno scatenato la ripresa delle ostilità e le ripercussioni che queste potranno avere sui delicati equilibri internazionali. Non vorremmo mai dire “ci mancava solo questa!”, ma è chiaro che in una fase di confronto/scontro tra grandi potenze, quale quella che stiamo vivendo, ogni questione ha la sua importanza e può investire molti più attori di quelli direttamente coinvolti. Gli attori in questione non sono certo semplici “comparse”: si chiamano Stati Uniti, Russia, Turchia e Iran (forse anche la UE…). Cercheremo, anzitutto, di capire quale sia stata l’escalation, partendo da una breve cronaca dei fatti. Il 5 settembre è partita l’accusa armena agli azeri, di aver ucciso un proprio militare alla frontiera. Alla notizia, rilanciata dal ministro della Difesa di Jerevan, ha fatto eco la risposta del collega azero, che in sostanza ha detto che tutto sarebbe partito da alcuni scontri a fuoco scatenati dagli armeni. Non si tratta, per la verità, della prima “scaramuccia” di confine: già ai primi di agosto Baku aveva imputato al vicino l’uccisione di due militari e il ferimento di altri dodici. In questo caso, però, si è trattato di scontri molto più importanti, sia in termini di violenza, che di estensione geografica. Tra il 12 e il 14 settembre si sono verificati gli scontri a fuoco più intensi al confine – con tanto di attacchi di artiglieria e droni da parte azera – che hanno raggiunto anche centri abitati armeni distanti dal confine, allargando così e di molto lo spettro del conflitto. In base a stime ufficiali non definitive ci sarebbero stati 77 morti tra i militari dell’Azerbaijan e 135 nelle fila dell’Armenia, senza contare numerosi feriti e migliaia di sfollati. Come già nel 2020, la situazione tra le parti in conflitto sembra essersi rovesciata nei rapporti di forza. Se il conflitto dei primi anni Novanta si era concluso, non ufficialmente e senza un trattato di pace, con la vittoria degli armeni, che si erano assicurati il controllo della regione del Nagorno Karabakh (e di varie aree limitrofe), costringendo centinaia di migliaia di azeri ad abbandonare le proprie case, oggi è l’Azerbaijan in condizione di netta superiorità. Vanta una popolazione che è il triplo di quella armena, cui si accompagna l’importante sviluppo economico legato agli idrocarburi, che oggi fanno gola più che mai agli occidentali, per le ragioni che ben conosciamo: basti pensare al TAP, il gasdotto che porta l’oro blu dal giacimento offshore azero Shah Deniz, situato nel Mar Caspio, fino alle coste pugliesi, che garantisce importanti flussi destinati, almeno in parte, a compensare le forniture russe. Baku ha investito molti di questi proventi nel rafforzamento delle proprie forze armate, tanto che già nel 2020 si era potuta rifare della precedente sconfitta, scatenando quell’offensiva che le aveva consentito di riprendersi praticamente tutti i territori adiacenti il Nagorno Karabakh, assieme ad una parte della stessa regione (ricca di gas e petrolio. Il nuovo assetto territoriale era stato ratificato dal cessato il fuoco del 9 novembre 2020, negoziato dalla Russia. In tale occasione erano stati gli armeni a fuggire (si è parlato di decine di migliaia di persone), mentre coloro che sono rimasti nella regione (ricordiamo, a maggioranza armena) si sono messi sotto la protezione dei contingenti russi. Nei mesi di aprile e maggio del 2022 il presidente azero Ilham Aliyev e il primo ministro armeno Nikol Pashinyan avevano parlato, in occasione dei colloqui di Bruxelles sotto l’egida della UE, di “advance discussions” per arrivare alla firma di un trattato di pace, ma nel frattempo le cose sono cambiate. Il ruolo della Russia, prezioso mediatore di pace del proprio “cortile di casa”, si è molto indebolito. Sempre più impegnata sul fronte ucraino, Mosca non ha più molte energie da investire nel processo di pace tra i due contendenti; il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, lo ha in qualche modo confermato quando ha dichiarato che “Il presidente sta naturalmente facendo ogni sforzo per contribuire ad allentare le tensioni al confine”. Tornano alla mente le parole di Daniele Santoro, quando scrisse (Limes, novembre 2020) che “Mosca ha inoltre perso qualsiasi credibilità in Armenia (suo storico alleato), paese che resta incardinato nell’orbita russa unicamente per assenza di pretendenti alternativi.” Del resto, non mancano i rapporti russo azeri: l’interscambio commerciale con Baku ha sfiorato i tre miliardi nel 2021, facendo di Mosca uno dei primi partner, nonostante l’Azerbaijan mantenga ottimi rapporti con l’Ucraina, cui ha inviato importanti aiuti dopo lo scoppio del conflitto. Sulla carta gli armeni godono anche delle tutele offerte dalla Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (OTSC), l’alleanza militare difensiva tra Russia, Bielorussia, Armenia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, ma è chiaro che senza l’apporto decisivo di Mosca la garanzia rischia di restare solo sulla carta, tanto che gli stessi membri si sono limitati a esprimere la propria preoccupazione. Se l’indebolimento e/o altri impegni preminenti di Mosca (quale che sia l’interpretazione che si voglia dare) mettono fuori gioco, o perlomeno riducono fortemente le sue capacità negoziali, imputare solo a questo fattore lo scoppio delle nuove ostilità sarebbe riduttivo. Se è indubitabile che Baku si sia potuta giovare di questi fattori, esistono ulteriori valutazioni da fare. Cominciamo da una semplice constatazione. In teoria, l’aggressione ingiustificata (in pochi hanno creduto ai “sabotaggi” sbandierati come pretesto da Baku) nei confronti di uno stato sovrano, membro dell’ONU, dovrebbe dare vita a forti reazioni internazionali. Il fatto, però, è che l’Occidente è alle prese con altri problemi, in primis quello dell’approvvigionamento energetico, per cui difficilmente si metterebbero di traverso rispetto a un prezioso fornitore di gas e petrolio; e questo a Baku lo sanno perfettamente. Non a caso, pur esprimendo riserve e ribadendo la propria volontà di mediazione (al pari di ONU e OSCE), Bruxelles non ha fatto molto di più. E gli armeni non potrebbero attendersi aiuto neanche dall’Iran, visto che la Repubblica Islamica ha al proprio interno una importante minoranza azera (circa un quarto della sua popolazione ha tale origine, persino la guida suprema Alì Khamenei), con la quale non vorrebbe creare conflittualità o, peggio, scatenare pericolosi irredentismi. Inoltre, l’Azerbaijan ha un importante obiettivo strategico, che non fa nulla per nascondere: lo scorso anno il presidente Aliyev aveva esplicitato l’intenzione di creare un “corridoio” che, passando per la regione armena di Syunik, congiungesse la regione azera del Nakhchivan con la Turchia (aggiungendo che lo avrebbe realizzato con il negoziato o con la forza). La Turchia è un alleato di ferro di Baku – gli stessi azeri sono di etnia turcofona – oltre a inglobare nel proprio territorio sovrano una parte importante dell’Armenia storica, senza contare il capitolo nero del genocidio armeno di inizio secolo. Prima delle nuove ostilità con gli azeri, erano in corso tra Ankara e Yerevan delle trattative per una normalizzazione dei rapporti, ma l’aperto appoggio offerto da Erdogan a Baku – in questo sostenuto da una opinione pubblica fortemente filo azera – e le proteste degli armeni contro eccessive concessioni all’Azerbaijan (e, di riflesso, al suo alleato turco) stanno mettendo una seria ipoteca per ogni futura intesa. Non è certo un caso se le regioni armene sotto attacco si collochino proprio nella fascia meridionale del territorio armeno, per la creazione del famoso corridoio, pure fomentando l’irredentismo azero presenti in tali territori. Nonostante per il momento gli scontri siano cessati grazie alla tregua del 14 settembre, non è escluso che con tutti questi presupposti le tensioni possano riprendere in qualunque momento. L’unica soluzione, ancora una volta, sarebbe quella del negoziato, ma non difficilmente a questo punto si potrebbe parlare di trattative paritarie. Lo stesso premier armeno Pashinyan, scatenando le proteste popolari, ha cercato di preparare il suo popolo a pesanti concessioni, fino alla perdita dell’indipendenza del Nagorno Karabakh (formalmente azera, ma nei fatti sotto controllo armeno), nella consapevolezza che in uno scontro diretto i costi umani ed economici rischierebbero di essere molto più pesanti, a cominciare da quelli sopportati dagli armeni che vivono nelle regioni contese. Un negoziato condotto sotto il timore di scenari peggiori – le dichiarazioni degli azeri non lasciano ben sperare – non offrirebbero una prospettiva allettante per Jerevan, oltre ad alimentare l’idea che nel mondo ci siano diversi pesi e misure, a seconda degli interessi in gioco. Di sicuro la UE sta chiudendo uno o entrambi gli occhi rispetto a molte violazioni dei diritti umani commesse da Baku, comprese quelle sul fronte interno, prima e dopo l’inizio della nuova escalation: Marina Kaljurand, membro del Parlamento europeo e presidente della Delegazione per le relazioni con il Caucaso meridionale, ha scritto da poco sul suo profilo Twitter: “l’attacco militare su larga scala della scorsa notte dell’Azerbaigian contro molteplici obiettivi nel territorio della Repubblica dell’Armenia… Questa recente aggressione non provocata e ingiustificata contro il territorio sovrano dell’Armenia è l’ennesima violazione flagrante da parte dell’Azerbaijan della Carta delle Nazioni Unite, dell’Atto finale di Helsinki e della Dichiarazione trilaterale del 9 novembre 2020”. L’unica sponda offerta ultimamente all’Armenia – paese, giova ribadirlo, finora legato a Mosca, con la quale esiste anche un trattato bilaterale di mutua cooperazione – è venuta dagli Stati Uniti, i quali rispetto al conflitto hanno espresso serie preoccupazioni, invocando una rapida cessazione delle ostilità. Il 18 settembre, Nancy Pelosi, la speaker della Camera dei Rappresentanti, già al centro di polemiche per il viaggio a Taiwan dell’agosto scorso, ha compiuto un viaggio ufficiale in Armenia. E non è un fatto di poco conto, trattandosi della più alta carica istituzionale americana in visita nel paese dall’indipendenza (1991). Taluni osservatori l’hanno letta come il sintomo della volontà americana di attirare Jerevan nella propria sfera d’influenza, offrendo garanzie di protezione che la Russia non sembra più in grado di dare. Chiaramente sarebbe presto per trarre ogni conclusione, ma non è un’ipotesi da escludere. Come scriveva ad aprile scorso Simona Scotti, su Geopolica Info “La risoluzione delle controversie territoriali risulta quindi fondamentale non solo per porre fine alla violenza persistente e allo spargimento di sangue, ma anche per consentire a questi paesi di affermare la propria sovranità e perseguire le proprie politiche estere senza condizionamenti.” Vale per gli armeni, e non solo per loro.
di Paolo Arigotti