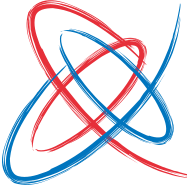Tagikistan e Kirghizistan sono tornati all’onore delle cronache nelle scorse settimane per via di un nuovo episodio, che si inserisce nel conflitto latente tra le due repubbliche ex sovietiche. I due paesi dell’area caucasica hanno una storia piuttosto tormentata e sono tuttora governati – similmente agli altri paesi “stan” – da regimi autoritari (considerati vicini a Mosca) e/o da ristrette oligarchie. Il Tagikistan divenne membro dell’URSS subito dopo la rivoluzione d’Ottobre, anche se la formalizzazione dello status di membro della federazione arrivò solo nel 1929, quando poté dirsi vinta la lotta contro la resistenza promossa dai guerriglieri islamici (i basmachi). Sospettoso nei confronti dei ribelli, l’allora governo di Mosca – nell’ambito di una politica di “taglia e cuci” della quale abbiamo diversi esempi nei 70 anni di esistenza dell’URSS (un caso per tutti, la Crimea) – decise di separare alcuni centri (Bukhara e Samarcanda) dal Tagikistan, per aggregarli al vicino Uzbekistan, del quale ancora oggi fanno parte: si trattò di decisioni motivate da fattori politici o strategici, per scindere due città considerate vicine alla cultura iraniana sciita, ritenuta fomentatrice dei moti di ribellione. Peraltro, la repressione o gli accorgimenti di epoca comunista non sono mai riusciti a sopire l’anima islamica tagika, che ha continuato ad operare in clandestinità. Non a caso, quando con la dissoluzione dell’URSS (1991) il paese proclamò l’indipendenza, l’evento coincise con lo scoppio di un lungo conflitto civile tra islamici ed eredi del potere sovietico, successivamente evolutosi in una guerra tra clan rivali, che provocò migliaia di morti e circa un milione di profughi. Solo nel 1997 venne siglato l’accordo di pace tra governo e combattenti islamici, anche se alcune delle frange più estremiste si rifugiarono nel vicino Afghanistan, da dove proseguirono le incursioni. Fu per contrastarle che il governo tagiko decise di chiedere l’intervento militare russo, che si è tradotto in una presenza permanente nel paese, che si protrae ancora oggi. La figura politica dominante nel panorama tagiko, in modo quasi ininterrotto dagli anni Novanta, è quella del presidente Emomali Rahmon (rieletto con il 90 per cento dei voti nel 2020), considerato un dittatore dall’organizzazione Human Rights Watch, per via della repressione del dissenso e delle limitazioni alle libertà personali e di espressione. Il paese viene considerato tra i più poveri dell’area caucasica: si calcola che circa la metà degli abitanti, ancora a metà del decennio scorso, vivesse in condizioni d’indigenza. Inoltre, rimane fortissima l’influenza politica e militare di Mosca: il paese fa parte della CSI, del CSTO, la “mininato” in “salsa” russa, e dello SCO, Organizzazione per la cooperazione di Shangai. La Russia ospita nel proprio territorio una importante comunità di lavoratori tagiki (circa un milione e mezzo), che rappresentano con le loro rimesse una voce fondamentale dell’economia nazionale. La federazione russa, inoltre, controlla gran parte delle risorse naturali del paese (alluminio, cotone, uranio, oro). Eppure, nonostante questo legame strettissimo con la ex “madrepatria”, va ricordata la collaborazione offerta gli USA durante la guerra in Afghanistan e gli importanti investimenti cinesi, sia infrastrutturali, che nel settore militare. Per quanto riguarda il Kirghizistan, anche questo paese – provincia dell’impero zarista dal 1876 – ha sopportato numerose criticità, prima e dopo l’instaurazione del governo dei soviet. Il regime comunista fu sempre contrastato dalla popolazione, nonostante all’epoca la nuova repubblica maturasse importanti progressi sul versante dell’industrializzazione e della scolarizzazione di massa. Tra gli altri, c’è stato il problema dei rapporti con la minoranza uzbeka, presente specialmente nella regione di Os, iniziato già in epoca sovietica e proseguito dopo l’indipendenza. Il paese, al pari del vicino tagiko, ha mantenuto fortissimi legami economici e militari con Mosca. Politicamente parlando, nella prima fase d’indipendenza emerse la figura di Askar Akayev, che diede vita a un regime corrotto e autoritario. Rimasto al potere sino al 2005, in quell’anno le accuse di brogli e la cosiddetta rivoluzione dei tulipani (una delle tante “colorate”) lo costrinsero alle dimissioni. Tuttavia, sotto il governo del suo successore, Kurmanbek Bakiev, molte delle speranze di riforme democratiche naufragarono, visto che il nuovo presidente diede vita a un regime del tutto analogo a quello di Akayev. Nuove proteste popolari portarono nel 2010 alla caduta del capo dello stato, mentre a luglio dello stesso anno divenne presidente una donna, Roza Otunbaeva, che lasciò il posto l’anno seguente a Almazbek Atanbayev. Anche negli anni a venire la storia delle elezioni ha continuato ad essere caratterizzata da accuse di brogli, fino ad arrivare all’elezione dell’attuale presidente, Sadir Japarov, arrivato al potere nel 2021, descritto dai media occidentali come un politico con tendenze nazionaliste e populiste. Similmente al vicino, nonostante i legami con Mosca, il Kirghizistan ha appoggiato gli USA, dopo l’11 settembre 2001, nelle operazioni militari condotte nella regione; altre analogie vedono il paese membro delle stesse alleanze a conduzione russo-cinese e beneficiare di importanti investimenti di Pechino, che pure in tal caso hanno coinvolto la cooperazione militare. In questo senso, potrebbe apparire paradossale il fatto che due stati, inseriti nel “cortile di casa” della Russia e membri delle stesse alleanze militari e strategiche, siano in conflitto (mai dichiarato) tra loro. Ma i fatti degli ultimi giorni non rappresentano purtroppo una novità: ben 150 sono stati gli scontri verificatisi nell’ultimo decennio, l’ultimo in ordine di tempo a maggio del 2021, quando si erano verificati pesanti scontri militari, con un bilancio di 55 morti e decine di migliaia di sfollati. Dopo alcune “baruffe” a gennaio scorso, stavolta (i nuovi dissidi sono iniziati il 14 settembre) si è parlato di 24 morti (per altre fonti sarebbero più di 80), mentre sono fioccate, come le altre volte, le accuse reciproche per la violazione degli accordi e dei confini. Il vertice SCO di Samarcanda del 15 e 16 settembre, del quale abbiamo già parlato, sembrava aver messo a tacere le armi, grazie alla mediazione di Vladimir Putin, che ha portato allo stesso tavolo i due presidenti, con la firma di una tregua. Parliamo, però, di un semplice cessate il fuoco, che non risolve minimamente le ragioni del conflitto e che non ne ha impedito una nuova deflagrazione. Il fattore scatenante è costituito essenzialmente da questioni di confine, che affondano le radici nella famosa delimitazione dei confini delle diverse repubbliche operata in epoca sovietica, mantenuta inalterata al momento dell’indipendenza. Se è vero che l’obiettivo perseguito all’epoca era la preservazione di una certa omogeneità etnica, ma non sempre il principio è stato rispettato. Nel caso tagiko e kirghiso il problema è appunto questo e porta un nome preciso: la regione kirghisa di Bakten, dove non a caso si sono consumati gli scontri degli ultimi giorni, con tanto di attacchi aerei, lanci di mortaio e bombardamenti. In questo luogo insistono due insediamenti tagiki (Vorukh e Kayragach), che però sono sotto la sovranità kirghisa, appunto per effetto della delimitazione fatta in epoca sovietica; incidenti si sono verificati anche nella provincia tagika di Sughd. Fin quando è esistita l’Urss (come insegna la vicenda della Crimea) il problema non si era mai seriamente proposto, ma dopo il 1991 sono emerse tutte le contraddizioni latenti, che finiscono per interessare circa un terzo dei mille chilometri che rappresentano il confine dei due stati, mai del tutto accettati da nessuna delle due parti. Non si tratta (come quasi mai avviene per ogni guerra) di mere questioni di principio: la regione montuosa di Bakten, al centro della contesa, garantisce l’accesso a importanti bacini idrici, in una regione duramente colpita dalla siccità; in altre parole, quella che si consuma da quelle parti è un esempio di guerra per l’acqua, delle quali abbiamo parlato affrontando la piaga della siccità; e non va dimenticato che i cambiamenti climatici stanno contribuendo ad aggravare la situazione. Ma non sarebbe solo questo, anche se non ufficialmente, l’unico pomo della discordia. Le zone in questione sono coinvolte da grossi flussi illegali di oppio, proveniente dall’Afghanistan, il cui controllo fa gola a tanti. Per completezza, ricorderemo anche l’esistenza di altri territori, interni al Kirghizistan, ma amministrati dall’Uzbekistan, nei quali la popolazione è prevalentemente tagika: un esempio è il distretto di Sokh, nella regione di Fergana, una sorta di linea di confine tra i due stati e il vicino Uzbekistan, riguardo la quale è stato però raggiunta lo scorso anno un’intesa di massima tra kirghisi e uzbeki. Putin, come dicevamo, ha cercato di trovare un modus vivendi tra le parti, visto che l’esplosione ricorrente di conflitti nel cosiddetto estero vicino rappresenta per il presidente russo ben più di una semplice grana, coinvolgendo due paesi alleati e dando così l’impressione di un non ottimale controllo della propria sfera d’influenza; a maggior ragione in questo momento, quando l’Ucraina assorbe gran parte delle sue energie. E non c’è in gioco solo l’aspetto strategico o del prestigio russo, visti i numerosi progetti che coinvolgono Tagikistan e gli altri paesi dell’area, coi quali Mosca ha tutto l’interesse a conservare ottime relazioni. Non è un caso se la Duma russa ha da poco approvato alcune misure che prevedono una serie di interventi previdenziali a favore dei lavoratori tagiki operanti sul suo territorio. E questo senza mai dimenticare che tutti i paesi “stan” sono fondamentali per la sicurezza di Mosca, che non può certamente permettersi defezioni nel cortile di casa, specialmente di fronte alle sirene e alle lusinghe provenienti da Occidente o da Oriente (l’amica Cina). Non depone a favore del presidente russo che la tregua negoziata a Samarcanda abbia avuto vita breve, con nuovi scontri nuove accuse reciproche di non stare ai patti: già si parla della convocazione della commissione intergovernativa per la delimitazione dei confini, ma gli oltre 150 scontri finora consumatisi non fanno ben sperare. Probabilmente la soluzione più efficace sarebbe una delle opzioni suggerite lo scorso anno da Filippo Costa Buranelli, docente di Relazioni internazionali nel Regno Unito, che scrivendo per l’ISPI parlò di “…un rafforzamento del processo di regionalizzazione, basato sulla consapevolezza tra le repubbliche dell’Asia centrale che i problemi di confine esistenti e la violenza ad essi correlata sono risolti al meglio dagli stessi paesi regionali. Ciò equivarrebbe ai primi passi verso un ordine dell’Asia centrale per quanto riguarda i meccanismi di risoluzione delle controversie, che potrebbero includere pratiche sia formali che informali.” In altre parole, una sorta di soluzione autogestita, senza pressioni o ingerenze di soggetti terzi, che potrebbe rivelarsi assai più efficace e durevole nel tempo.
di Paolo Arigotti