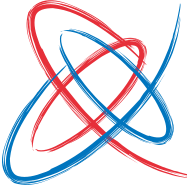di Antonio Petrillo
Già Rousseau respingeva con rigore qualsiasi criterio diverso dalla conoscenza e dalla qualificazione specializzata, di valutazione del “valore” della persona e lo riconoscevano come una mera espressione di un potere autoritario e discriminatorio. Ma da allora, con il sopravvento nel mondo delle imprese di una cultura del potere e dell’autorità il ricorso al “merito” ha sempre avuto il ruolo di sancire, dalla prima rivoluzione industriale, il potere indivisibile del padrone o del governante, e il significato di ridimensionare ogni valutazione fondata sulla conoscenza e il “sapere fare”, valorizzando invece, come fattori determinanti, criteri come quelli della fedeltà, della lealtà nei confronti del superiore, di obbedienza e, in quel contesto, dell’anzianità aziendale. Il ricorso al concetto di “merito”, utilizzato (anche in termini salariali) come correttivo di riconoscimento della qualificazione e della competenza dei lavoratori. La funzione antisindacale degli “assegni” personalizzati di merito, quando questi, oltre a dividere i lavoratori della stessa qualifica o della stessa mansione, finirono per rappresentare un modo diverso di inquadramento, di promozione e di comando della persona sanzionato, per gli impiegati, da una divisione normativa che nulla aveva a che fare con l’efficienza e la funzionalità, ma che sigillava la garanzia del posto di lavoro e la fedeltà all’impresa. Ma quello che è più interessante osservare è come, con la flessibilità ma anche con la responsabilità che incombe sul lavoratore sui risultati quantitativi e qualitativi delle sue opere, si sia accompagnato in Italia a una risorgenza delle forme più autoritarie del Taylorismo, particolarmente nei servizi, santificata non solo dal mito del manager che si fa strada con le gomitate e le stock options, ma dalla ideologia del liberismo autoritario. Con gli “yuppies” che privilegiano l’investimento finanziario a breve termine, ritorna così per gli strati più fragili (in termini di conoscenza) l’impero della meritocrazia. A questa nuova trasformazione (e qualche volta degrado) del sistema industriale italiano ha però contribuito l’egualitarismo salariale di una parte del movimento sindacale, a partire dall’accordo sul punto unico di scala mobile, che ha offerto, in un mercato del lavoro in cui prevale la diversità (anche di conoscenze) e nel quale diventa necessario ricostruire una solidarietà fra persone e fra diversi, una sostanziale legittimazione alle imprese che hanno saputo ricostruire un rapporto diverso (autoritario ma compassionevole) con la persona sulla base di una incomprensibile meritocrazia. Meriti e bisogni o capacità e diritti? Non è una questione di vocabolario: la meritocrazia nasconde il grande problema dell’affermazione dei diritti individuali di una società moderna. Accedere alle carriere sulla base dei propri meriti, piuttosto che delle raccomandazioni, contribuisce alla civiltà delle relazioni sociali. Dall’altro lato, però, la concezione meritocratica rischia di minare il senso di appartenenza ad una comune umanità e la propensione a relazionarsi agli altri sulla base dell’eguale considerazione e rispetto. Pur senza condurci al finale del libro sulla meritocrazia di Young, dove il narratore è ucciso da una massa inferocita di individui con un basso quoziente di intelligenza, il rischio è quello, già paventato dai moralisti scozzesi, di favorire la rottura dei legami sociali, inducendo gli individui a ritrarsi dalla «scena comune». Il peso della cultura meritocratica, peraltro, è da molti considerato una variabile importante nello spiegare la minore generosità dello stato sociale statunitense rispetto agli stati sociali europei. Richiami a visioni della vita come gara, ad uno stato sociale il cui obiettivo ultimo sia quello di fare a meno dello stato sociale stesso, espressi nel dibattito pubblico, mi sembrano, invece, riflettere un’oscillazione verso la concezione meritocratica, che rischia di lasciare insoddisfatte dimensioni importanti dell’eguaglianza e delle opportunità. In una Cassa non sana in merito allo sviluppo del lavoratore, diventano un pò ridicole e fuori luogo proposte c.d. regressive, soprattutto se a promuoverle sono (e chi altri?) una
amministrazione che è essa stessa la causa ultima del problema. E’ come chiedere ad un virus di auto-eliminarsi oppure di provvedere da solo a somministrarsi gli antibiotici. Laddove alcuni godano di ampi privilegi, il personale si divide in caste e la possibilita’ di accedervi per merito non rende quel clima assolutamente indispensabile e sereno per una piu’ giusta e produttiva attività. Porto a sostegno di questa posizione, la riflessione di Gustavo Zagreblesky (noto giurista italiano). Scrive Zagrebelsky, “lo spirito dell’uguaglianza”: “L’uguaglianza non e’ l’omologazione, la massificazione […] l’uguaglianza come il contrario del privilegio […] Il privilegio ha conseguenze nefaste nello spirito pubblico. Se gli accessi ai livelli sociali superiori sono aperti, la societa’ e’ sottoposta allo stress del carrierismo diffuso, con ben noti prezzi da pagare: disasgio, frustrazioni, si genera invidia sociale, un male terribile che, accumulato, produce instabilita’ nella psiche degli individui, tensione collettiva e distruzione.”