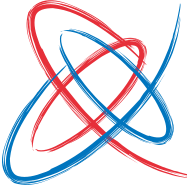Non sono in tanti, oggi, specie tra i più giovani, a ricordare che fino al 1991 esisteva in Europa, ai confini orientali con l’Italia, uno stato unitario e federale, chiamato Jugoslavia.
Nei primi anni Novanta, praticamente sotto gli occhi del mondo intero, si sarebbe consumata la tragedia delle guerre iugoslave, che avrebbe determinato la dissoluzione della Federazione, con una serie di conflitti, succedutisi quasi senza soluzione di continuità fino al 1999. Non vogliamo qui ripercorrere la storia di quei sanguinosi eventi, che causarono innumerevoli vittime ed il ritorno, dopo il 1945, della guerra sul suolo europeo, bensì soffermarci in breve sulla storia della nascita e delle modalità di formazione dello stato jugoslavo, quale possibile chiave di lettura dei fatti. Dobbiamo fare un salto indietro di quasi un secolo, a quel fatale 1918.
La conclusione della Grande guerra portò con sé la fine di quattro grandi imperi multietnici: ottomano, russo, tedesco, austro ungarico. Per quanto di nostro interesse, ci dedicheremo a quest’ultimo, la cui implosione è all’origine della nascita di diverse nuove realtà politiche, tra le quali annoveriamo il primo embrione della futura Jugoslavia.
Lo stesso nome è evocativo del suo carattere composito: stato degli slavi del sud. Va detto, però, che questa non fu la prima denominazione ufficiale del nuovo stato balcanico, che nel 1918 venne battezzato Regno dei Serbi dei Croati e degli Sloveni. Uno stato serbo indipendente esisteva da circa un secolo: furono le due rivoluzioni del 1804 e 1815 a consentirgli di rendersi autonomo dall’impero ottomano (peraltro la capitale Belgrado sarebbe stata presidiata dai turchi fino al 1867), mentre l’assetto istituzionale sarebbe stato quello del principato fino al 1882, per poi divenire un regno sino al 1918. Fu un’idea di matrice illuministica, sulla scia dei comuni legami linguistici e culturali, a favorire la nascita del nuovo stato, che riuniva al proprio interno, oltre ai tre gruppi etnici ufficiali, anche i montenegrini, i macedoni, i musulmani bosniaci ed altri minoritari, quali italiani, ungheresi, albanesi, rom, cechi, slovacchi, rumeni, bulgari, turchi, ucraini. Se il mito dell’unione dei popoli dell’Illiria (nome dell’antica provincia romana) aveva affascinato la borghesia croata, altrettanto non era stato per i loro omologhi di Slovenia e Serbia, assai più legati alle specifiche tradizioni nazionali: in questo senso si può affermare che il nuovo stato, ufficialmente ispirato al rispetto delle diverse autonomie e nazionalità, non nasceva sotto buoni auspici. La nascita del primo stato balcanico fu il frutto del progetto espansionista serbo, sostenuta dai popoli slavi (sloveni, croati, bosniaci) soggetti alla dominazione austro ungarica, che avevano perso ogni speranza di vedersi riconosciuto uno statuto autonomistico e videro nel progetto jugoslavo il male minore.
A queste istanze, va aggiunta la volontà delle nazioni uscite vincitrici dalla Grande guerra, che si prefiggevano l’obiettivo di stendere una sorta di cordone sanitario, fatto di tanti nuovi stati, attorno alla neonata Russia bolscevica, come avvenuto per altre entità politiche (p. es. la Cecoslovacchia).
Alla volontà espansionistica della grande Serbia, uscita ingrandita dalle guerre balcaniche del 1912 e 1913, ora si univano, pertanto, le istanze e volontà politiche di altre nazioni, a cominciare da quella croata e slovena. Agli eventi successivi contribuì, in qualche modo, l’assassinio a Sarajevo dell’Arciduca Francesco Ferdinando (1914), erede al trono imperiale austriaco e grande sostenitore di un rinnovato assetto federale dei regni asburgici: la sua morte violenta, in questo senso, rappresentò assieme al pretesto per lo scoppio del primo conflitto mondiale, il tramonto di ogni speranza per la tenuta dell’impero e la spinta verso nuovi progetti politici, tra i quali la nascita della Jugoslavia.
Quale fu l’assetto del nuovo regno? Nel periodo tra le due guerre possiamo distinguere due grandi fasi politiche.
La prima che copre il primo decennio di storia unitaria, va grossomodo dal 1918 al 1929. In questo periodo, sulla scena politica si affacciano tre grandi gruppi politici: i partiti serbi, le forze localiste e le sinistre (di ispirazione marxista e non). I partiti politici serbi erano diversificati al loro interno, tra quelli caratterizzati da un programma centralista e conservatore, come il Partito radicale serbo, fino ad arrivare al Partito democratico, fautore di un orientamento più riformista, riconducibile alla sinistra non marxista; tutte queste formazioni avevano ramificazioni anche fuori dal territorio della Serbia propriamente detta. Tra i localisti ricordiamo il Partito contadino croato e quello liberale sloveno, oltre che l’Unione popolare musulmana (in rappresentanza dei tradizionali interessi dei seguaci dell’islam nei vari territori jugoslavi) e quello federalista del Montenegro. Pur con i dovuti distinguo, queste forze erano ispirate da un progetto autonomista, che non metteva in discussione l’assetto unitario dello stato, ma che contrastava le mire centraliste di Belgrado.
I partiti riconducibili alla cosiddetta sinistra “di classe” erano una congerie di forze socialdemocratiche o di ispirazione comunista, articolate al loro interno su base regionale e/o per obiettivi politici: per esempio il partito socialista moderato era ostile ai bolscevichi e promuoveva una collaborazione con le cosiddette forze borghesi.
Non va dimenticato che, fin dai primi anni, si affacciano sulla scena politica forze estremiste di destra, tra le quali va ricordato, per le implicazioni successive, il Partito croato del diritto di ispirazione ultranazionalista e fautore dell’indipendenza croata, al cui vertice si insedierà ben presto un avvocato originario dell’Erzegovina: Ante Pavelić.
Un quadro politico così composito e frammentario era in qualche modo rappresentativo della situazione del Paese, foriera di una costante instabilità politica, cagionando una marcata debolezza del Regno sullo scenario internazionale. La perdita di importanti territori imposti alle conferenze di pace, tra i quali zone strategiche della Dalmazia e la città di Fiume in favore dell’Italia, rappresentarono un grave smacco per i governi jugoslavi, dando nuova linfa alle voci dell’estremismo interno.
Il rispetto delle autonomie nazionali, sancito (sia pur timidamente) dalla Costituzione del 1919, in realtà non sarebbe mai stato del tutto rispettato; lo stesso può dirsi per le libertà politiche ed individuali. Già nel 1921 Corona e Governo vararono una serie di misure che limitavano le prerogative del Parlamento, andando oltretutto nella direzione di un sempre più marcato accentramento in favore dell’etnia serba; inoltre, le repressioni contro le forze di ispirazione comunista ed una sapiente strategia di divisione delle forze localiste agevolava questa tendenza. In Macedonia si assistette già in quegli anni ad una politica di denazionalizzazione, che si avvalse del supporto di formazioni paramilitari serbe (i cosiddetti cetnici), formate in prevalenza da ex combattenti della Grande guerra, che non lasciava ben sperare sui futuri assetti politici. Ogni tentativo di cooperazione, in particolare tra serbi e croati, si faceva ogni giorno più difficile, mentre le elezioni politiche del 1927 (le ultime formalmente libere) restituirono un quadro sempre più frammentato e ingovernabile.
La politica accentratrice e contraria alle autonomie perseguita da Belgrado contribuì ad esasperare gli animi, fomentando ovunque (perfino nella moderata Slovenia) l’emersione di una profonda insofferenza verso il Governo centrale, che sfociò nella nascita o sviluppo di movimenti e formazioni paramilitari indipendentiste. Si arrivò così al 1928, quando le profonde divisioni interne ed il fallimento dell’accordo tra serbi e croati mise fine al Regno multietnico. La Corona prese in mano la situazione, ricorrendo al pugno di ferro. Il Sovrano Alessandro Karađorđević era imbevuto di cultura imperiale di stampo zarista e mal celava il suo disprezzo verso qualunque forma di parlamentarismo o pluripartitismo; pertanto, nel giorno dell’Epifania (il Natale ortodosso) del 1929 si rivolse al Paese, e, facendo appello all’interesse generale, dichiarò abolita la Costituzione del Regno (cosiddetta di San Vito), assumendo i pieni poteri, ed esautorando di fatto Governo e Parlamento. Tutte le libertà politiche e personali (compresa quella di stampa), così come ogni istanza autonomista, furono cancellate dal colpo di stato, mentre alla guida dell’Esecutivo, responsabile esclusivamente dinanzi al monarca, venne nominato il comandante militare della Guardia reale. Tutti i partiti politici, tranne quelli “legalmente ammessi”, furono sciolti d’autorità. Si tornava, in sostanza, alla monarchia assoluta, dove il sovrano era l’unico centro del potere, sostenuto dalle forze armate: ogni forma di dissenso, sul modello dell’Italia fascista, veniva duramente repressa. Se sul versante economico furono varate una serie di riforme ispirate al modello statalista del Fascismo italiano (compresa l’abolizione dei sindacati e il divieto di serrata e sciopero), su quello politico, fu proclamata la nascita della Jugoslavia: una nuova denominazione ufficiale dello stato, che sostituiva la precedente; vennero, inoltre, imposti un’unica lingua (il serbocroato) e l’uso dell’alfabeto latino. Da questo momento in avanti, non si parlerà più di Serbia, Croazia o Slovenia, bensì di Jugoslavia “integrale” ed unitaria. Il colpo di mano della Corona non venne accettato pacificamente dalle formazioni preesistenti, specie quelle di matrice etnica: tra le altre, sulle ceneri del disciolto Partito croato del diritto, nasceva l’Organizzazione rivoluzionaria croata insorta, meglio nota come Ustascia (in croato insorti). Queste ultime svolgeranno, assieme ad una martellante propaganda contraria alla “nuova” Jugoslavia, azioni violente di contrasto al nuovo assetto istituzionale. Nel 1931, sulla scia di proteste internazionali, Alessandro ristabilirà il regime costituzionale e pluripartitico, ma nei fatti cambierà ben poco ed il potere resterà saldamente nelle mani della Corona. Circa tre anni dopo, durante un viaggio ufficiale in Francia, il sovrano venne assassinato per mano di un estremista appartenente agli Ustascia croati. La morte violenta del re non fece registrare grandi rimpianti, né in patria né altrove. La scomparsa del monarca dittatore cambiò ben poco lo scenario politico, anzi il suo tentativo di creare una Jugoslavia unita, senza più confini interni, parve dare i suoi frutti quando, in occasione di un censimento ufficiale degli anni successivi, si riscontrarono numerose dichiarazioni di nazionalità jugoslava, piuttosto che serba o croata o slovena. É stato ipotizzato che qualora Alessandro avesse fatto leva sulle componenti più illuminate delle varie etnie, forse il suo progetto politico avrebbe avuto miglior sorte.
Quello che non cambiò, come si diceva, era il regime interno: anche sotto il nuovo sovrano e successore di Alessandro, Pietro, rimase in piedi un assetto che presentava molti tratti in comune con il Fascismo, quando non faceva a quest’ultimo esplicito richiamo. Le elezioni politiche del 1935, formalmente libere, diedero la maggioranza al Partito nazionale jugoslavo ed il Reggente Paolo diede l’incarico di formare il nuovo governo a Milan Stojadinović, simpatizzante dei regimi fascista e nazista, oltre che convinto anticomunista.
La sua linea politica seguiva due grandi direttrici: avvicinare la Jugoslavia all’Asse (niente di più facile per lui, viste le dichiarate simpatie per quei regimi) e cercare di risolvere l’annoso problema dei rapporti tra serbi e croati, concedendo a questi ultimi maggiori spazi di autonomia per salvaguardare la stabilità interna. Le altre nazionalità del Regno vennero giudicate, a torto o a ragione, maggiormente controllabili, ragion per cui l’attenzione si concentrò sulla Croazia, cercando, in particolare, di mettere all’angolo le forze più estremiste.
L’avvicinamento all’Asse si concretizzò, negli anni prima della guerra, in un rapporto preferenziale con l’Italia fascista e la Germania nazista, con la stipula di diversi ed importanti accordi politici ed economici. Sul fronte interno vennero introdotti elementi di economia corporativa e feroci persecuzioni anticomuniste, mentre in Italia furono chiusi i campi di addestramento per gli Ustascia, in cambio dell’amnistia concessa da Belgrado. I tentativi sempre più evidenti di trasformare la Jugoslavia in un paese fascista alienarono al Primo ministro le simpatie del Reggente, che, anche su pressione dei francesi, che volevano contrastare l’attrazione della Jugoslavia nella sfera dell’Asse, decise di destituirlo, per poi espellerlo dal Paese con l’accusa di aver ordito un colpo di stato. Il nuovo governo, guidato da un uomo di fiducia della Corona, mantenne un buon rapporto con le potenze dell’Asse, concedendo ampie autonomie ai croati. Quest’ultima decisione, però, fu osteggiata dalle élite serbe più oltranziste e dalla Chiesa ortodossa, che non risparmiarono al nuovo Esecutivo pesanti critiche; malumori furono espressi dagli stessi croati, che giudicavano troppo blande le concessioni del governo, nonché dalle altre etnie del Paese, che si ritenevano ingiustamente discriminate. Le questioni interne, però, passarono in secondo piano, perché nel frattempo era scoppiata la Seconda guerra mondiale, che ebbe pesanti ripercussioni sulla storia jugoslava. L’Italia fascista, nell’ottobre del 1940, attaccò la Grecia: la campagna militare si rivelò ben presto rovinosa, costringendo Mussolini ad una umiliante richiesta di aiuto all’alleato tedesco. Hitler, temendo che la Grecia potesse divenire una base d’appoggio per i nemici, accorse in suo aiuto, e questo implicò che tutta l’area balcanica dovesse entrare nella sua orbita: venivano gettate le basi per la successiva invasione del Paese. É vero che Belgrado, sulla scia delle rapide vittorie tedesche, non aveva mai abbandonato la politica di avvicinamento all’Asse, ma ora gli veniva richiesta – per meglio dire imposta – l’adesione al Patto tripartito, sottoscritta il 25 marzo 1941.
La scelta suscitò molti malumori in patria: dimissioni di ministri, proteste dell’influente Chiesa ortodossa, come dell’alta finanza ebraica locale e degli esponenti della corrente politica filofrancese. Queste divisioni tra filotedeschi e filoccidentali portò ad un nuovo colpo di stato, che determinò la caduta del Reggente: salì al trono Pietro II, che scelse come nuovo capo del governo un generale avverso ai nuovi e più stretti legami instaurati con l’Asse. Hitler non perse tempo, ordinando alle sue truppe, appoggiate dagli italiani, di invadere contemporaneamente Jugoslavia e Grecia. I territori furono spartiti tra le potenze dell’Asse e i loro alleati (tra i quali Ungheria e Bulgaria), mentre il 10 aprile 1941 a Zagabria venne ufficialmente proclamata la nascita della Croazia indipendente, alla cui guida si insediò Ante Pavelić, leader degli Ustascia.
La nuova Croazia indipendente, comprendente oltre al territorio della nazione propriamente detta anche parte della Slavonia, Bosnia Erzegovina e Vojvodina, sarebbe stata in realtà solo dei tanti stati (e governi) fantoccio manovrati dai tedeschi. Nonostante ciò, si sarebbe rivelata una delle nazioni più allineate con l’alleato nazista, soprattutto nella politica antisemita e di pulizia etnica, portate avanti con inaudita ferocia ed a costo di efferati crimini. La sua sedicente autonomia fu più che altro il frutto di una scelta politica delle potenze dell’Asse, che facendo leva sulle frustrazioni e desideri autonomisti e sulle forze più estremiste, ottennero così di avere uno strumento di penetrazione politica ed economica in una regione strategica.
Gli Ustascia, sostenuti dagli italiani che li vedevano come il mezzo per consolidare la propria egemonia nell’Adriatico, instaurarono un regime violento e razzista, in collaborazione con i loro alleati musulmani della Bosnia. Ergendosi a difensori dell’Europa contro la minaccia “slava e bolscevica”, fissarono nel fiume Drina il confine tra occidente ed Asia, improntando la loro politica alla più dura segregazione razziale contro le razze “impure”, accompagnandola con azioni sempre più violente. Autentici pogrom furono organizzati contro i serbi (appartenenti alla “razza slava inferiore”), ebrei, zingari, colpiti da misure discriminatorie sempre più stringenti, analoghe a quelle adottate dai nazisti in Germania e nei territori occupati.
In particolare, contro i serbi ortodossi fu scatenata una repressione di tale violenza da sorprendere gli stessi nazisti: un terzo di quella popolazione, presente nei territori controllati dagli Ustascia furono deportati in Serbia (occupata dai tedeschi e retta da un governo collaborazionista), un terzo convertiti forzosamente al cattolicesimo, la restante parte massacrata, con l’ausilio di un articolato sistema di campi di concentramento. Si è calcolato che, dalla presa del potere sino alla fine della Seconda guerra mondiale, la Croazia detenga il ben triste primato di aver massacrato o lasciato uccidere la maggior parte della propria popolazione. La resistenza agli occupanti, in particolare da parte dell’etnia serba, si divise in due grandi filoni: i cetnici guidati da Draza Mihailović, che propugnavano la restaurazione della Jugoslavia a guida serba, ed i comunisti, il cui leader indiscusso era, già dal 1937 Josip Broz, detto “Tito”. I primi si caratterizzavano per un acceso nazionalismo e anticomunismo, che li poneva in netto contrasto con i partigiani titini. Le due componenti non potevano essere più diverse per appartenenza politica e finalità: ogni tentativo di unificarle nella comune lotta contro l’invasore si rivelò impossibile, posto che ognuna delle due voleva semplicemente assoggettare l’altra. Pur di ostacolarsi, ciascuna delle parti non esitò a stringere accordi con gli occupanti, perfino con gli Ustascia croati, ma alla fine sarà Tito a spuntarla, forte dell’appoggio degli alleati che lo giudicavano più affidabile, uscendo come il vincitore assoluto della battaglia contro gli invasori. Fautore di un assetto federale per la Jugoslavia del dopoguerra, divenne nel 1946 leader indiscusso del Paese, posizione che avrebbe conservato fino alla morte avvenuta nel 1980. In un primo momento alleato dell’Unione Sovietica, avrebbe dato un’impronta rigidamente socialista e stalinista al suo regime, ma questo indirizzo avrebbe avuto vita breve. Nel 1948 si consumò la definitiva rottura con Stalin, al quale Tito non voleva riconoscere il ruolo di dominatore assoluto della vita politica dell’Europa orientale convertita al comunismo, portata alle estreme conseguenze dai dissidi tra i due dittatori sulle questioni giuliana e greca; questo influenzerà in maniera decisiva la politica interna ed estera jugoslava dei successivi decenni, a cominciare dal varo del movimento dei “non allineati”, che vedrà in Tito uno dei maggiori promotori. Parlando del fronte interno, Tito, nel rispetto dell’ortodossia marxista leninista che improntava il suo regime, scelse di fare della Jugoslavia socialista e federale una “comunità di nazioni”, nella quale avessero lo stesso peso e uguali diritti tutte le componenti etniche. Al tal fine, lavorò per sminuire peso ed importanza delle forti componenti serba e croata, mediante una sapiente politica di ridimensionamento dei contendenti, che passò anche attraverso l’eliminazione (in taluni casi fisica) delle frange più estreme. Si trattò di un complicatissimo gioco di pesi e contrappesi, che faceva leva sulle istanze autonomiste e su un rigido controllo dal centro, nel quale la personalità e leadership politica di Tito giocò un ruolo preminente e di garanzia per tutti. Il problema si sarebbe presentato una volta scomparsa la sua figura e, purtroppo, la storia degli anni ’90 ha rappresentato una conferma dei timori espressi ancor prima della sua morte, senza tralasciare per questo luci ed ombre che aleggiavano sul leader storico.
La dissociazione di Tito dall’alleanza con Stalin fruttò importanti aiuti economici dall’occidente, che agevolarono non poco lo sviluppo economico ed il varo di una nuova politica improntata alla cosiddetta autogestione economica ed al decentramento istituzionale. Queste scelte furono tradotte in pratica a partire dai primi anni ’60, senza però dare i risultati sperati. In molti casi, difatti, causarono importanti spinte inflazionistiche e crescita della disoccupazione, che colpirono le aree meno sviluppate: in pratica tutte le repubbliche, tranne Slovenia e Croazia che vantavano assetti produttivi e standard di vita più favorevoli. Si può ipotizzare che pure in questi fattori, con i crescenti malumori tra un nord più ricco ed un sud più arretrato, possano essere ricercate le concause dei sanguinosi conflitti della fine del secolo scorso. A fronte della crisi che attanagliava il sistema, Tito valutò fosse meglio accrescere le autonomie territoriali, il che però avrebbe alimentato, accogliendo la costruzione di cui sopra, il divario ed il desiderio di defilarsi, anche con l’indipendenza, insito nelle regioni più ricche del Paese. I rigurgiti nazionalisti si fecero sempre più forti, acutizzati dalla crisi economica, ed interessarono Slovenia e Croazia, ma anche Kosovo e Bosnia.
Tito decise di fronteggiare la crisi del sistema con la forza, reprimendo ogni tentativo di sedizione ed attuando, di fatto, una nuova politica di centralismo, con gravi purghe che colpirono i dirigenti croati nei primi anni ’70. Se in un primo momento la forza parve dare i suoi frutti, alla lunga il pugno di ferro non avrebbe soffocato i risorgenti e mai sopiti nazionalismi interni, destinati prima o poi ad esplodere, specie col rapido invecchiamento del leader storico. Prima di morire, il “Presidente a vita” (che, in tale veste, conservò sino alla fine il controllo del partito e delle forze armate) stabilì che la guida del Paese sarebbe stata affidata ad una presidenza collegiale, formata dai capi di stato delle sei repubbliche (Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia) e delle due province autonome (Kosovo e Vojvodina), nell’illusione che un sistema di concertazione e contrappesi avrebbe tenuto unita la Jugoslavia anche dopo la sua scomparsa, avvenuta il 4 maggio del 1980. Si sarebbe rivelata, purtroppo per il defunto Maresciallo, un’illusione destinata ad avere vita breve.
I disordini scoppiati in Kosovo nel 1989 saranno soltanto la prima avvisaglia di una lenta ma inesorabile agonia, che avrebbe portato, di lì a poco, alla dissoluzione della Jugoslavia.
Nello stesso anno nel quale crollava il Muro di Berlino e veniva abbattuta la cortina di ferro, che aveva diviso in due l’Europa per più di quarant’anni, sarebbe stata, difatti, la provincia autonoma a maggioranza albanese ad essere il teatro di importanti disordini, favorendo paradossalmente la rinascita e rinvigorirsi del mai sopito nazionalismo serbo.
Il neo eletto presidente serbo, Slobodan Milošević, col sostegno della Chiesa Ortodossa e delle Forze armate, ma anche della maggioranza della popolazione che aveva aderito al suo progetto di restaurazione della Grande Serbia, varò un nuovo indirizzo politico. Egli riuscì in breve tempo a sostituire i vertici politici del Montenegro e quelli delle province autonome di Vojvodina e Kosovo con uomini a lui fedeli, facendo arrestare i leaders politici dissenzienti e costringendo, con la minaccia del ricorso alla forza militare, i singoli governi ad approvare una modifica costituzionale che, di fatto, cancellava l’autonomia delle due province. In questo modo, il leader serbo ottenne il controllo di ben quattro delle otto entità politiche rappresentate nella Presidenza collegiale posta, per volontà di Tito, al vertice della Federazione. A quel punto, per disporre di una maggioranza gli sarebbe bastato un solo voto in più ed avrebbe avuto il controllo della Jugoslavia, realizzando l’obiettivo di restituire alla Serbia una posizione di egemonia. Gli eventi precipitarono rapidamente.
É importante ricordare che, sulla scia dei grandi mutamenti che investirono l’Europa orientale tra la primavera ed il dicembre del 1989, quando – uno dopo l’altro e più o meno pacificamente (con la sola eccezione della Romania) – caddero i regimi comunisti al potere dal secondo dopoguerra e si avviò un processo di democratizzazione, nella stessa Jugoslavia venne riconosciuto il multipartitismo e, nel 1990, per la prima volta nelle consultazioni convocate in tutte le repubbliche, una pluralità di liste, non più solo quelle riconducibili alla lega dei comunisti iugoslavi, si contesero il consenso elettorale. L’esito delle votazioni si rivelò decisivo per i successivi eventi, perché ovunque si affermarono partiti di ispirazione nazionalista e/o indipendentista, che mettevano in discussione la tenuta della Federazione voluta da Tito. Milošević, in tal senso, non era certo il solo a rispolverare i vecchi miti del nazionalismo (pur dichiarandosi ancora socialista), così come i ricordi e le ombre del periodo della Seconda guerra mondiale, onde piegarle alle sue finalità politiche.
Nello stesso periodo c’era un altro leader, il Presidente croato Franjo Tuđman, arrivato al potere con le elezioni del 1990, che aveva ben altre idee sul futuro della Jugoslavia e della sua nazione, facendo leva sui sentimenti patriottici del suo popolo. E non era finita qui. Un altro Capo di Stato, il Presidente della Slovenia Milan Kučan, aveva avviato un processo di democratizzazione interno avanzato rispetto alle altre repubbliche iugoslave, e non aveva nessuna intenzione di farsi sottomettere da Belgrado.
La Federazione era prossima al collasso; in quella che sarà l’ultima riunione congiunta della Lega dei comunisti jugoslavi, in occasione del XIV congresso del 1990, esplosero le divisioni: croati e sloveni abbandonarono i lavori, per avviarsi sulla strada della secessione e della dichiarazione d’indipendenza. Si era oramai alla vigilia delle guerre jugoslave, che annientarono ben presto quello spirito di fratellanza ed unità dei popoli slavi del sud tanto caro a Tito, in fondo più apparente che reale; il sistema aveva retto per circa quarant’anni grazie al carisma (e uso della forza) di Tito, ma l’esplosione di divisioni mai sopite e la crisi economica avevano minato irrimediabilmente la Federazione, destinata a dissolversi dopo un lungo e sanguinoso conflitto, il più cruento che l’Europa ricordi dopo la fine della Seconda guerra mondiale. In ordine di tempo, prima il conflitto in Slovenia, poi quelli in Croazia e Bosnia Erzegovina, con l’ultima appendice in Kosovo, dove tutto era iniziato, portarono alla fine della Jugoslavia, che ha lasciato il posto a sette stati sovrani: oltre a quelli già citati la Serbia, il Montenegro, la Macedonia del nord (unica entità politica non coinvolta direttamente nell’ultima guerra europea).
di Paolo Arigotti